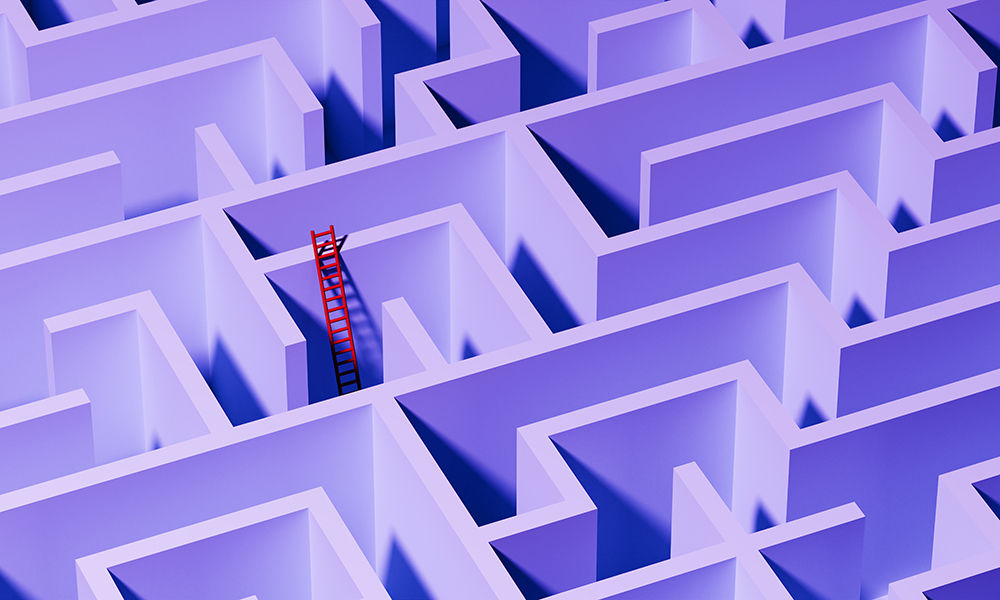Come i dark pattern ci guidano senza che ce ne accorgiamo
Qualche giorno fa ho provato a cancellarmi da una newsletter. Non ricordavo nemmeno di essermi iscritto. Cerco il classico link in fondo alla mail, lo clicco, e vengo portato su un
L’indagine PIAAC dell’OCSE mostra un calo preoccupante delle competenze cognitive in Italia, evidenziando una trasformazione profonda nel nostro rapporto con la conoscenza.
Nel marzo 2025, l’OCSE ha diffuso i risultati del secondo ciclo dell’indagine PIAAC, restituendo una mappa puntuale dello stato delle competenze cognitive nei Paesi ad alto reddito. In Italia, oltre un terzo della popolazione adulta non è in grado di comprendere un testo di media complessità; percentuali analoghe riguardano le competenze numeriche e la capacità di risoluzione autonoma di problemi in contesti non prevedibili. Non si tratta di una variabile residuale confinata a fasce marginali della popolazione: è una dinamica trasversale che segnala una trasformazione più ampia relativa al rapporto tra soggetto e conoscenza, tra tempo e comprensione, tra complessità e accesso. Una trasformazione avviata, o quanto meno radicalmente accelerata, dall’uso estensivo – e frequentemente acritico – dell’intelligenza artificiale, che non si limita ad automatizzare operazioni ma riformatta, in modo sistematico, le modalità con cui accediamo alle informazioni, le elaboriamo, le giudichiamo. L’efficienza dell’algoritmo sostituisce progressivamente il tempo del discernimento; la sintesi predittiva spodesta l’interpretazione.
Si assiste – o forse ammettiamolo, noi stessi lo stiamo già sperimentando – a una contrazione dello spazio cognitivo disponibile: una regressione della mente che riguarda non tanto l’intelligenza in sé, quanto la sua capacità di tenuta, di profondità, di permanenza. A essere colpita è la facoltà di discernimento autonomo, l’attenzione prolungata, la continuità del domandare. Il nostro rapporto con la conoscenza sembra stia attraversando un lento processo di disattivazione: e ciò che si ritrae per primo – senza gesti eclatanti, ma con effetti profondi e misurabili – è proprio quella disposizione a formulare giudizi complessi in modo indipendente.
L’autonomia del pensiero non consiste nell’accumulare informazioni né nel verificarne la coerenza formale, ma nel sostenerne la densità, nell’attraversarne la complessità, nel trasformarle in senso.È un processo che implica tempo, memoria, attenzione prolungata – e che si affina, necessariamente, attraverso la pratica, l’errore, l’esposizione all’incertezza. In questo senso, il tempo – non come durata ma come condizione – rappresenta l’effettiva variabile critica del nostro presente. Ed è proprio sul tempo, difatti, che interviene l’intelligenza artificiale, proponendosi come antidoto alla lentezza, come dispositivo di accelerazione: elabora, compara, restituisce in millesimi di secondo, laddove prima erano necessari gesti, attese, discernimento.
In questa sequenza ottimizzata di operazioni rapide e formalmente corrette, tende a dissolversi proprio quello spazio intermedio in cui la mente, per natura, si esercita: un’area di passaggio, di attesa, di esposizione, in cui il pensiero si costruisce non per automatismi, ma per attrito. La velocità produce sintesi, non comprensione; restituisce ordine apparente, non profondità. Si delinea così il paradosso che ci attraversa: mentre celebriamo l’intelligenza delle macchine, disinvestiamo sulla nostra.
La tecnologia ha sempre ridefinito i confini della conoscenza – la stampa, l’enciclopedia, Internet – ma mai come ora si è consolidato un affidamento così radicale, e così acritico, a uno strumento capace di emulare, e in certi casi superare, la nostra capacità di elaborazione.
L’erosione del pensiero critico non è un effetto collaterale né un costo marginale della trasformazione tecnologica in corso: è un processo strutturale, pervasivo, che si manifesta in una progressiva sospensione dell’esercizio quotidiano dell’intelligenza come attività deliberata. Le capacità cognitive dell’individuo – ancora integre nella loro potenza – non vengono meno per obsolescenza biologica, ma per mancata attivazione: ciò che si sta smarrendo, lentamente, è il riconoscimento sociale, culturale e individuale del valore stesso del pensare. Non perché manchino gli strumenti per coltivarlo – considerati l’accesso universale ai dati e la moltiplicazione dei contenuti – ma perché si è modificato il rapporto tra l’individuo e l’elaborazione, tra l’informazione e l’interpretazione. Pensare, oggi, non è tanto difficile quanto superfluo. O meglio: diventa progressivamente superfluo nel momento in cui altri – automatismi, interfacce, sistemi predittivi – sembrano in grado di svolgere per noi ciò che un tempo definivamo, con naturalezza, attività della mente.
Pensare – nella sua accezione più piena, ovvero analizzare, vagliare, comprendere prima di concludere – è oggi un’attività rara, giacché richiede una postura che non si lascia sedurre dalla rapidità della risposta, ma si ostina a trattenere l’interrogativo, a sopportare l’intervallo, a tollerare il peso del tempo. Un tempo che non è quello cronometrico delle macchine, ma quello organico della mente umana, che ha bisogno di decantare, sedimentare, collegare, dubitare (e che – se privata di questa possibilità – si atrofizza, non per incapacità, ma per deprivazione).
L’intelligenza artificiale, dunque, nel suo funzionamento impeccabile, non è la causa di questo fenomeno: ne è la manifestazione, il detestabile specchio riflettente. Il problema risiede difatti nel modo in cui abbiamo iniziato ad accettare – spesso con entusiasmo, ancor più frequentemente con inerzia – di spostare fuori di noi non solo operazioni, ma intere facoltà cognitive. Non si tratta più di automatizzare funzioni ripetitive: ciò che progressivamente le deleghiamo è la facoltà stessa di generare senso, articolare giudizi, sostenere un pensiero. È qui che il confine tra il supporto e la sostituzione si assottiglia fino a rarefarsi pericolosamente. La forma più alta dell’autonomia intellettuale si riduce così a una sorveglianza passiva su ciò che l’algoritmo ci restituisce già confezionato come plausibile. E, ricordiamolo, quando si riduce la capacità di leggere il mondo, si affievolisce anche la possibilità di trasformarlo.
La macchina cancella così, in silenzio, il sacro umano errore come occasione generativa. L’efficienza si è elevata a principio ordinatore, scalzando progressivamente ogni altro criterio – incluso quello, irriducibile, della comprensione. Ma la comprensione non è una funzione dell’efficienza; e non lo è il giudizio, che richiede confronto, sospensione, profondità, né tantomeno l’immaginazione, che si muove per deviazioni, analogie, aperture. Pensare significa eccedere la logica dell’ottimizzazione, sostare in una zona che l’algoritmo – per quanto avanzato – non può calcolare né prevedere. È in quella zona improduttiva, apparentemente superflua, che si articola ancora la possibilità di un’intelligenza non delegata.
Il cervello, come ogni sistema vitale, ha bisogno di esercizio: esternalizzare la memoria, l’analisi, la scelta significa – nel tempo – cedere porzioni sempre più estese del nostro spazio mentale; e ciò che si affida in modo continuativo a un agente esterno, si disattiva.
È questo che si intende per scarico cognitivo: un alleggerimento della memoria di lavoro che, se adottato in modo episodico, può risultare funzionale; ma che, se diventa struttura, finisce per ridurre l’esposizione necessaria all’apprendimento, l’attrito su cui si forma la competenza. Non rende più liberi, né più lucidi: semplicemente, rende meno pronti. E meno capaci.
Non siamo i primi a interrogarci su come la tecnica possa ridurre, anziché espandere, le capacità umane. Socrate temeva che la scrittura avrebbe annichilito la memoria; Spitzer ha fatto riferimento alla demenza digitale; oggi, la delega cognitiva assume la forma di una dislocazione strutturale dell’intelligenza fuori dall’organismo. Ma nessuno di questi allarmi ha mai trovato una risposta sistemica, perché tutti – anche i più avvertiti – si sono scontrati con l’egemonia dell’utile.
E nulla, oggi, appare più utile dell’intelligenza artificiale. Ma utile per cosa? Italo Svevo, in uno dei suoi scritti più potenti e meno conosciuti, L’apologo del Mammut, affida all’uomo una delle più penetranti immagini della sua inadeguatezza strutturale. L’uomo, fragile, inquieto, inetto all’adattamento, sopravvive solo perché si rifugia «all’ombra di un animale più forte». È un essere che «vuole tutto», ma che non è disposto a cedere nulla di sé per adattarsi. L’innovazione – quella vera, darwiniana – si genera nell’attrito tra l’insufficienza e la necessità. Ma quando l’uomo decide di rinunciare alla propria imperfezione come motore evolutivo, e si affida all’“altro” – che sia l’animale forte o, oggi, l’algoritmo – smette di evolversi. Cessa, come scrive Svevo, «dalla vera vita, ch’è l’evoluzione».
Così, mentre ci illudiamo di progredire, potremmo in realtà stare regredendo verso una forma più sottile di servitù. Una servitù che non impone catene, ma solleva dalla responsabilità di pensare. L’uomo «torvo e malcontento», che un tempo sviluppava «ordigni fuori del proprio organismo», oggi li elegge a surrogati di sé. E piuttosto che coltivare la sacra imperfezione – quella che interroga, sbaglia, rallenta, ma crea – come leva dell’intelligenza, la cede; e, con essa, cede anche il diritto di decidere chi è.