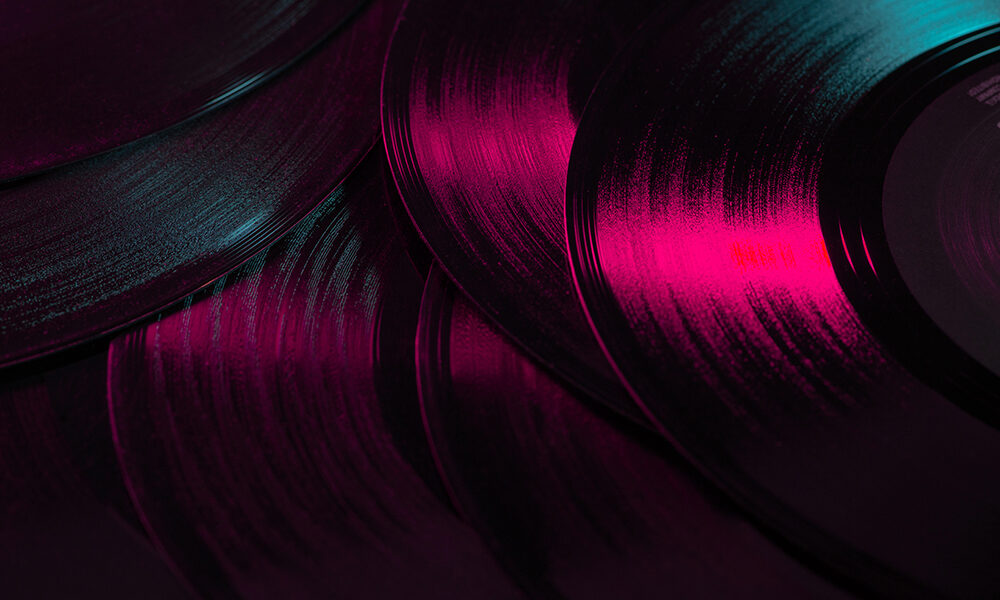Carta d’identità moltiplicata
Una ragazza apre il suo profilo su TikTok, magari con il sogno di diventare influencer, e sceglie un filtro che le modifica il viso: occhi più grandi, pelle liscia e perfetta in m
Per la prima volta dal paleolitico 1987 sul mercato americano sono stati venduti più 33 giri che CD. Ma non è ricominciata una nuova era per il giradischi.
Chiunque sia (ancora) appassionato di musica “fisica”, e collezioni dischi in vinile, avrà prima o poi vissuto la stessa deprimente esperienza. Quella cioè di constatare, nelle reazioni degli ospiti che entrano in casa e osservano straniti le pareti di dischi, come agli occhi della stragrande maggioranza delle persone si appaia come degli anacronismi viventi, dei polverosi residuati novecenteschi forse innocui ma sicuramente “strani”. Le domande in genere vanno dal classico «ma li ascolti tutti?» (risposta consigliata: «sì, ma non insieme») al surreale «si sentono ancora?» per finire al fantastico – il sottoscritto può testimoniare – «ma hai anche l’attrezzatura per usarli?». L’”attrezzatura” si chiamerebbe giradischi, o impianto stereo, o piatto, a seconda dell’abitudine. E sì: senza quella, quegli strani cosi neri e rotondi non si possono usare.
Eppure. Quella che sembrerebbe un’ovvietà, in questo sempre più assurdo presente in cui i concetti di digitale, analogico, vintage, fisico e virtuale si intrecciano in modi impensabili fino a pochi decenni orsono, forse così ovvia non è. A dimostrarlo è una recente ricerca di una data-company americana chiamata Luminate, presentata all’ultimo South by Southwest Festival di Austin, Texas. Secondo questa analisi condotta tra gli acquirenti di dischi in vinile americani (ma si può presumere un identico risultato a livello mondiale), metà di questi non possiede un giradischi. Se si somma a un’altra statistica di qualche anno fa che aveva stabilito che la metà di chi possiede un giradischi non lo usa mai, se ne deduce che tre quarti di chi compra vinile lo fa per svariati motivi, ma tra questi di sicuro non rientra l’ascoltarli.
Il che getta una luce del tutto particolare sul tanto strombazzato “ritorno del vinile”, che proprio nel 2022 ha celebrato un evento epocale. Per la prima volta dal paleolitico 1987, infatti, si sono venduti sul mercato americano più 33 giri che CD, con un ritorno economico di più di un miliardo di dollari per i primi e di meno di cinquecento milioni per i secondi. La più classica delle vittorie di Pirro, certo. Il CD è un formato moribondo da ormai più di vent’anni: prima l’i-Pod, poi il downloading (legale o meno) e infine lo streaming hanno reso obsoleti, nonché anti-ecologici e scomodi, i dischetti argentati che negli anni 90 sembravano l’ultima e definitiva frontiera della tecnologia musicale. L’eliminazione dei lettori cd dalle auto di ultima generazione ha dato il colpo di grazia. Quindi superare le quote di mercato del compact disc non sembrerebbe questa impresa sensazionale, tenendo anche conto che i due formati insieme costituiscono appena il 15% del giro d’affari legato al consumo di musica, con il resto appannaggio di Spotify, Apple Music e simili.
Ma seppur di nicchia, il revival del vinile è indubbiamente un dato di fatto. Tenuto in vita da irriducibili appassionati – e dai dj – per quasi un quarto di secolo, l’oggetto ha ritrovato fascino persino agli occhi delle nuove generazioni, e non si contano più le sequenze di film e serie tv nelle quali si vedono spuntare scaffali di LP (come si chiamavano una volta) in stanze super-cool e super-hipster. Quelli che probabilmente non si vedono, in quelle scene e in quelle stanze, sono i giradischi. E la ricerca di Luminate sembrerebbe confermarlo.
Ma allora per quale motivo vengono comprati i dischi in vinile? La risposta è interessante perché sottolinea un mutamento significativo nel rapporto con la fisicità degli oggetti di consumo e/o con i manufatti artistici. Da un lato si sente l’esigenza di recuperarla, in reazione alla tendenza irreversibile alla smaterializzazione e alla virtualità dell’era digitale. Dall’altro questa esperienza tattile, concreta, tridimensionale è sempre più slegata da quello che dovrebbe essere il reale valore d’uso e il senso dell’oggetto. Al di là delle connotazioni modaiole, per cui viene considerato semplicemente qualcosa da mostrare e quindi di “instagrammabile” (equivalente a pietanze, gattini, scarpe, tatuaggi, tramonti sul mare ecc.), il vinile diventa il simbolo di un rapporto privilegiato e più intenso con l’artista che lo ha prodotto. Nel gergo del marketing chi acquista dischi in vinile in base a queste motivazioni rientra in una nuova categoria di “consumer-persona”: quella del cosiddetto super-fan.
Il super-fan è qualcuno che non compra-per-ascoltare ma bensì compra-per-possedere. Il disco è, sostanzialmente, un avatar del suo essere fan dell’artista X. Un modo per dimostrare sostegno economico tangibile (in un momento storico in cui i guadagni dei musicisti tendono pericolosamente al ribasso), ma anche un oggetto di merchandising al pari di una maglietta o un adesivo con il logo della propria band preferita.
È proprio questa necessità di “connessione” diretta tra fan e artisti che spiega, fino a un certo punto, il paradosso economico più evidente in comportamenti di questo tipo. I prezzi dei dischi in vinile, che diventano sempre più cari vista l’esiguità del mercato e il numero ridotto di luoghi in cui viene fabbricato, derivano in gran parte da un processo produttivo finalizzato a inserire in un supporto fisico un segnale musicale. Quindi i trenta (spesso anche quaranta o cinquanta) euro che vengono pagati per un disco in vinile dipendono proprio da ciò che a due terzi di chi li acquista oggi non interessa più: il loro essere una fonte sonora.
Un comportamento apparentemente irrazionale, ma da quando la razionalità ha mai auto qualcosa a che fare con l’essere un fan? O, meglio ancora, un super-fan?