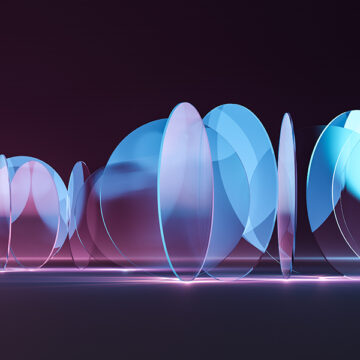E se a frenare la natalità non fossero solo fattori economici, ma anche le aspettative sul ruolo dei genitori? Changes ne ha parlato con Davide Cino, ricercatore in Pedagogia Generale e Sociale all’Università degli Studi di Milano-Bicocca.
Negli ultimi anni si parla sempre più spesso di intensive parenting, un modello di genitorialità caratterizzato da coinvolgimento costante, pianificazione e controllo sulla vita dei figli. Nato negli Stati Uniti negli anni ’90, oggi è diffuso anche in Europa e in Italia, indipendentemente dalle risorse economiche delle famiglie. Ma questo approccio – basato sull’idea che le azioni dei genitori determinino direttamente il futuro dei figli – potrebbe avere un impatto anche su un tema cruciale: la denatalità. Ma è veramente così? E quanto incide questo modello sulla decisione di non fare figli o di fermarsi a uno solo? Changes ne ha discusso con DavideCino, ricercatore in Pedagogia Generale e Sociale presso l’Università degli Studi di Milano-Bicocca, Dipartimento di Scienze Umane per la Formazione “Riccardo Massa”.
Nel 2018 il New York Times definiva l’intensive parenting come “una genitorialità emotivamente assorbente, ad alta intensità di lavoro e finanziariamente costosa”. Lei come lo definisce?
Io lo vedo come una filosofia educativa che attribuisce ai genitori un potere quasi deterministico: si pensa che le loro azioni condizionino in modo diretto e permanente la vita dei figli. Questo genera un forte investimento, soprattutto sulle madri, che devono aggiornarsi, programmare, gestire ogni aspetto. Da qui nascono stress, ansia e un carico di aspettative anche sui bambini, spinti ad aderire presto a un modello performativo.
Perché questo modello nato negli Stati Uniti si è diffuso anche in Italia?
L’intensive parenting nasce tra gli anni ’50 e ’90 negli Usa, con coach e psicologi che spingevano sull’idea di responsabilizzare l’individuo. In Europa e in Italia ha attecchito quando si è passati da una cultura collettivista a una individualista: crescere un figlio è diventato un progetto personale, da gestire in proprio. Il problema è che, in un contesto con scarsa mobilità sociale, questo modello genera ansia anche nei genitori più abbienti, che si accorgono di non poter garantire davvero il futuro sperato.
Dedicarsi in toto ai figli significa diventare genitori migliori?
Ci sono aspetti positivi: l’abbandono dell’autoritarismo e una maggiore attenzione al benessere dei bambini. Ma se tutto è responsabilità tua – dal cibo bio alla scuola, fino al modo in cui mascheri la stanchezza – la pressione diventa insostenibile. Inoltre, permane un approccio di genere: la madre è ancora vista come naturalmente più predisposta alla cura, mentre il padre resta in una posizione di supporto. Così anche i modelli di coppia rischiano di replicare squilibri.
E i figli? L’intensive parenting li rende davvero “migliori”?
Non ci sono prove. L’educazione non è deterministica e le famiglie non sono sistemi chiusi. Non basta controllare tutte le variabili per assicurare un futuro positivo. Anzi, a volte l’abbondanza di stimoli e possibilità può generare malessere invece che benessere.
C’è un legame tra intensive parenting e denatalità?
Alcune ricerche dimostrano che gli ideali di questo modello – disponibilità economica, tempo, spirito di sacrificio, competenze – possono scoraggiare le coppie dall’avere più di un figlio. In Germania si è visto che molti rinunciano al secondo o terzo figlio. In Svezia, invece, grazie a un welfare solido, l’intensive parenting non ha inciso sulla natalità. Questo mostra che non è il modello in sé a essere un ostacolo, ma la sua interazione con un sistema sociale poco di supporto, come quello italiano.
Cosa bisognerebbe fare per invertire la rotta?
Occorrono due azioni parallele: culturali ed economiche. Da un lato serve dissociare la cura dal genere, promuovendo un modello di genitorialità equa. Dall’altro, sono necessarie politiche strutturali: congedi paritari, servizi educativi accessibili, stipendi adeguati, mutui sostenibili. Anche la conciliazione lavoro-famiglia deve valere per entrambi i genitori, non solo per le madri. Diversamente, rischia di diventare una penalizzazione di carriera. Se vogliamo rilanciare la natalità, dobbiamo alleggerire il peso che oggi grava soprattutto sulle donne.