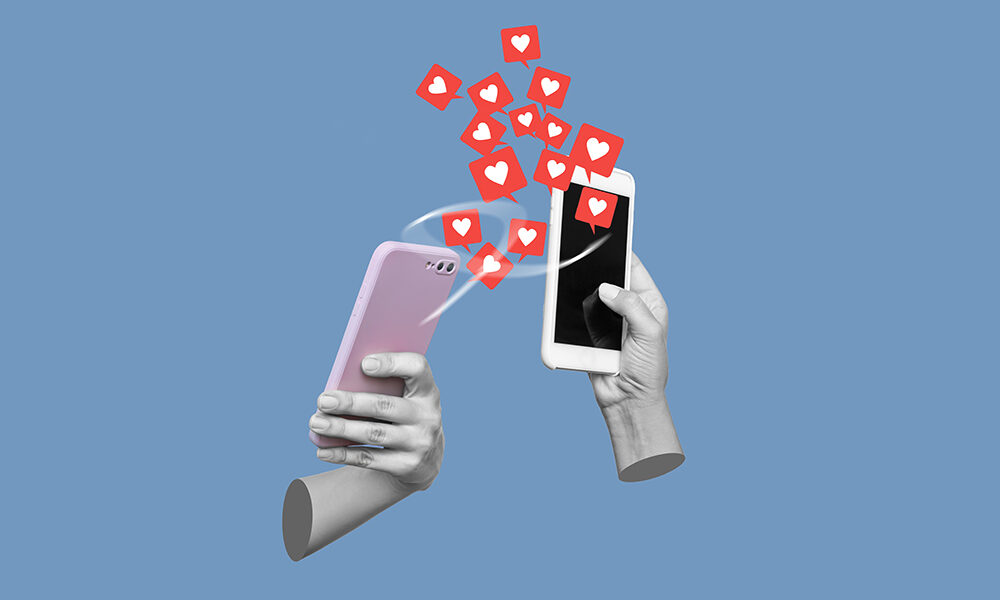Carta d’identità moltiplicata
Una ragazza apre il suo profilo su TikTok, magari con il sogno di diventare influencer, e sceglie un filtro che le modifica il viso: occhi più grandi, pelle liscia e perfetta in m
Condividere storie ed emozioni nell’onlife ha un impatto significativo soprattutto sugli adolescenti. Così l’io prevale sul noi e diventa più importante farsi notare che rapportarsi agli altri. Changes ne ha parlato con Giuseppe Riva.
«Online pensiamo di intrattenere relazioni pari a quelle nella vita vera. Ma non è così. Se poi a cadere nell’equivoco sono gli adolescenti, si rischiano mancanza di empatia e di apertura al diverso. E così, alla fine, invece di personalità autonome e indipendenti, ci troviamo davanti a soggetti per i quali dire io prevale sul dire noi». Lo sostiene Giuseppe Riva, psicologo all’Università Cattolica di Milano e autore di Io, loro, noi-Le relazioni nell’era dei social e dell’IA (Il Mulino). Changes gli ha chiesto di spiegare quali sono le conseguenze dell’uso massiccio dei social sui ragazzi.
Instagram ha inaugurato un profilo per minorenni: è un bene?
È già qualcosa di meglio rispetto a prima. Questo account che ha una serie di protezioni e di default viene visto solo da minorenni e amici dei minorenni. Resta però il problema di base: i social succhiano tempo, cosa che non viene ridotta con questo account, e un adolescente non ha ben chiara la differenza tra online e offline. Per dirla con un neologismo creato da Luciano Floridi, vivono una onlife o interrealtà.
Perché è un problema vivere una onlife?
I meccanismi della vita vera e digitale sono differenti. Nella quotidianità abbiamo, per esempio, la sincronizzazione, che “accorda” le onde cerebrali delle persone, creando, a poco a poco, tramite discussioni e screzi, un legame tra persone anche diverse per inclinazioni, gusti, opinioni. Nel mondo online i gruppi sono composti da soggetti omogenei: di conseguenza, mentre il rapporto con il diverso gradualmente riduce le distanze con l’altro, mi avvicina a chi non la pensa come me, online non c’è allargamento di orizzonti e allenamento all’ascolto altrui. Un adolescente, che deve formare la sua identità e trovare nuovi punti di riferimento, nel mondo digitale incontra solo una parte del mondo possibile, si conforma a ciò che il suo gruppo sostiene o si modella su 10 influencer che gli ha proposto l’algoritmo. Non sviluppa, cioè, una personalità autonoma né indipendenza di giudizio.
Lei sostiene che l’ambiente digitale modifica il modo in cui organizziamo le informazioni, quello che lei chiama brainframe
Sì, lo fa ogni tecnologia. Prendiamo la scrittura: la sua adozione implica un nuovo sistema di organizzazione della conoscenza, cioè un nuovo brainframe. In questo caso, invece di affidarmi ala memoria, sviluppo maggiormente l’abilità di decifrare alcuni segni su carta. Insomma, a una modifica tecnologica corrisponde un adeguamento cognitivo.
Quali sono le conseguenze dell’uso dei social sull’organizzazione cognitiva degli adolescenti?
Alcuni livelli di attività neurale non vengono più attivati. I primi sono i neuroni GPS, che sono stati scoperti qualche decennio fa dai coniugi Edvard e May-Britt Moser Moser, vincitori di un Nobel per la medicina nel 2014 insieme con John O’Keefe. In sostanza, sono neuroni che si attivano quando il soggetto entra in uno spazio specifico e giocano un ruolo cruciale nella costruzione della memoria autobiografia. Per dire, sono uno studioso se vado in biblioteca; uno studente perché vado a scuola; un tifoso perché vado allo stadio. Insomma, la mia identità biografica dipende dai luoghi. Online invece questi neuroni non si attivano perché l’ambiente digitale è un non luogo, e per un ragazzo è più difficile capire chi è, perché non ha un appiglio fisico su cui costruire la sua identità.
Online non vengono attivati neppure i neuroni specchio?
Esattamente. Questi sono neuroni che si attivano quando vedo gli altri che svolgono certe attività e le “rispecchiano”. Invece assistere ad azioni altrui online non ha lo stesso effetto di attivazione. Nel digitale i ragazzi vedono solo soggetti che ballano, cantano, compiono azioni positive, sono tutti felici. Non c’è posto per la depressione o la tristezza. E allora, non imparando più dalla vita reale a riconoscere le emozioni complesse o negative negli altri, un adolescente è in difficoltà quando le prova. Per di più, una vita prevalentemente online ha altre conseguenze nell’ambito emotivo: al posto dell’empatia, che è una risposta consapevole a ciò che un altro, di persona, mi racconta e mi fa capire, subentra il contagio emotivo, ovvero l’inclinazione a subire una sollecitazione emotiva. Per esempio, un video di un bacio tenero o di una protesta violenta può essere costruito strategicamente per suscitare reazioni specifiche negli utenti digitali. Gli adolescenti si trovano quindi in balia di una manipolazione continua, in cui da un lato non sono in contatto con sé stessi, dall’altro vivono emozioni eterodirette. Un esperimento condotto da Facebook, in cui sono stati mutati i contenuti mostrati nei profili nelle persone, ha dimostrato come sia stato possibile alterare gli stati emotivi di 700 mila persone senza che lo notassero.
Ma allora le relazioni digitali non sono vere relazioni?
Lo sono, ma sono meno complete. È come battere la spalla a una persona per incoraggiarlo o mettere un like: l’intensità è diversa. In più, privilegiare una modalità di relazione digitale rispetto a una reale, disattivando, come dicevamo, la capacità di sviluppare l’empatia, vuol dire ridurre gradualmente lo spazio per la cooperazione tra soggetti sostituendolo con l’autopromozione. Lo vediamo anche nella comunicazione: anziché parlarsi, ormai le persone si mandano dei vocali. La mancanza di simultaneità trasforma la comunicazione tra soggetti in informazione, ovvero in qualcosa che io voglio dirti, in un’affermazione di me. L’altro, insomma, è sempre meno un partner e sempre più un interlocutore cui mostrare le mie attività o chiedere qualcosa. E progressivamente, in questa modalità di relazione “unidirezionale”, svanisce il senso di appartenenza a una comunità: l’io prevale sul noi, è più importante farsi notare che rapportarsi agli altri.
Tuttavia, lei non ritiene che i social siano un male. Perché?
Al contrario, se si aggiungono a relazioni vere, sono molto utili per mantenere i rapporti vivi, non obbligando le persone a condividere necessariamente lo spazio e il tempo. Il problema nasce se per un ragazzo diventano la dimensione sociale prevalente. D’altra parte, i social sono “comodi”: non devo negoziare con chi ha opinioni divergenti dalle mie, entro ed esco quando voglio, non vengo in contatto con la diversità. Il rischio è che ci si rinchiuda in una digitalità facile e controllata invece che avventurarsi nella fisicità complessa della realtà.
Lei suggerisce di introdurre una sorta di patentino per gli adolescenti che vogliono accedere ai social. Cosa consiglia ai genitori?
La cosa più utile sarebbe incoraggiare i ragazzi a inserirsi in una comunità fisica. Che sia lo sport, o il gruppo scout o l’oratorio, non importa. La frizione dell’esperienza reale, benché più faticosa dei social, è l’unico modo di formare personalità equilibrate e interessate agli altri.