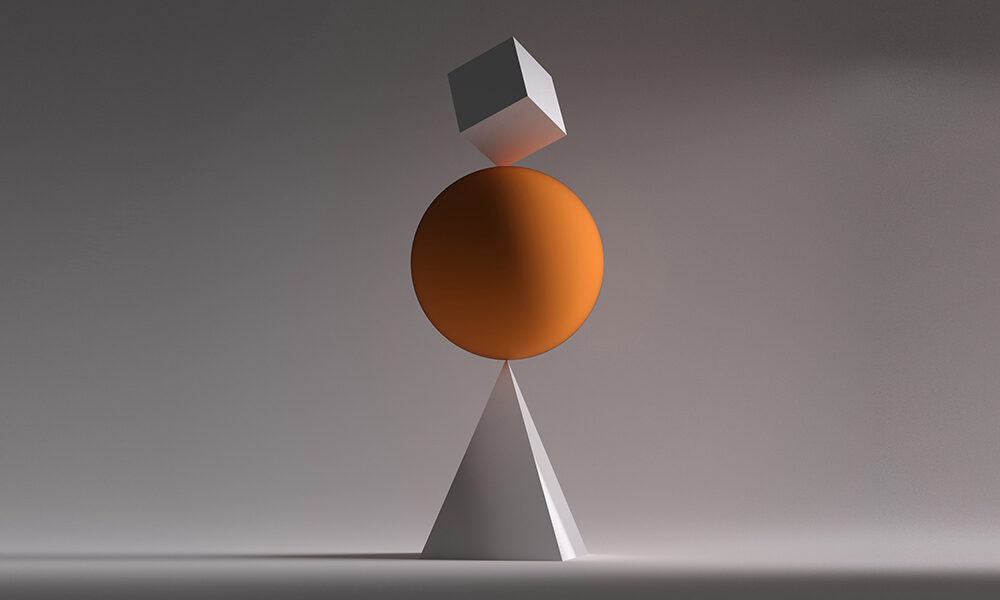La pandemia ha mandato in crisi il modello di business dell’economia del lavoro a chiamata mettendo in luce lo squilibrio di potere tra lavoratori, capitale e giudizi degli utenti.
La pandemia ha reso le società della Gig economy e i loro lavoratori essenziali per vivere in condizioni di lockdown e, paradossalmente, ha messo in crisi il modello di business delle piattaforme mettendo in luce lo squilibrio di potere tra lavoratori e capitale: l’azienda detiene la piattaforma tecnologica, gli algoritmi e i dati ma si libera da ogni responsabilità sociale per i lavoratori che rendono la piattaforma redditizia. Se questo andava bene fino a ieri, oggi qualcosa è cambiato il rischio di reputazione, legale, normativo a cui le società della Gig economy possono andare incontro non piace più ai grandi investitori. Così fattorini del cibo e autisti privati, idraulici e baby sitter ma anche programmatori e designer che trovano lavoro in rete, a chiamata e su richiesta, stanno combattendo una battaglia di uguaglianza con gli altri lavoratori.
Il fronte dei diritti dei lavoratori è aperto ma resta il giudizio degli utenti: ciascun lavoratore dell Gig economy può essere valutato dal cliente per la prestazione offerta. E proprio come accade ad un bistrot in voga, il lavoratore sale o scende in classifica. Rischiando comunque di essere allontanato dall’azienda. Con un click e sulla base dei giudizi espressi dagli utenti. «Gli algoritmi ormai segnalano anche i lavoratori meno efficienti e da licenziare, secondo loro. Una prospettiva poco rassicurante se si tiene conto che queste tecnologie sono spesso poco affidabili e tendono a replicare nei propri risultati una buona dose di pregiudizi di genere, razziali, sociali dei programmatori. Eppure il management tramite algoritmi ormai va ben oltre le piattaforme. Sempre più aziende ricorrono a software e intelligenza artificiale per selezionare il personale, o controllare l’attività dei lavoratori minuto per minuto, con braccialetti elettronici ma anche contando il numero di battiti alla tastiera, le email inviate, le conversazioni e l’attività su internet», spiega a Changes Valerio De Stefano, docente di Diritto del lavoro all‘Università di Lovanio (Belgio), in libreria con Il tuo capo è un algoritmo (Laterza, Bari, 2020).
«I sistemi di valutazione della performance esistono da secoli in tutti i settori. Ogni dipendente è soggetto al potere di controllo, che è funzionale all‘erogazione di premi o all‘imposizione di sanzioni. Ma la contraddizione di molti modelli di business alternativi consiste nell’aver sottratto il sistema ai contrappesi che nel tempo sono stati messi a punto dal legislatore, dalla giurisprudenza e dalla contrattazione collettiva. Contribuendo a un processo di disumanizzazione e mercificazione del lavoro», conferma Antonio Aloisi, coautore del volume con De Stefano e docente di Diritto del lavoro all’Università IE di Madrid, dove è anche Marie Skłodowska-Curie Fellow.
Del resto la battaglia per i diritti dei lavoratori delle piattaforme viene da lontano. “Sono un essere umano, non un algoritmo” si legge nella lettera che il 25 dicembre 2014 i lavoratori di Amazon scrissero a Jeff Bezos, chiedendo condizioni di lavoro migliori. Sono trascorsi ormai 9 anni da quel mercoledì 2 novembre 2005, quando il fondatore di Amazon introdusse Mechanical Turk, la piattaforma online in cui aziende, università ed enti di ricerca commissionano micro-lavori che le macchine non sanno (ancora) svolgere, ad una folla di lavoratori a cottimo. I “turchi” – perlopiù indiani e americani – trascrivono testi, rispondono a sondaggi, inseriscono sottotitoli e correggono la pronuncia degli assistenti virtuali, per renderli più umani. C’è chi racconta di aver guadagnato 15 dollari dopo 40 ore di lavoro, mentre Amazon, per l’attività d’intermediazione, sembra trattenere un terzo da ciascun pagamento.
La piattaforma rievoca il Turco Meccanico, l’automa scacchista costruito nel 1770 per stupire e compiacere Maria Teresa d’Austria e la sua corte. Sembrava una macchina imbattibile, ma c’era un trucco: un maestro di scacchi scomodamente nascosto al suo interno. «Bezos evoca appunto lo stesso fenomeno: legioni di lavoratori umani fanno il lavoro che le macchine non sanno fare, ma rimangono nascosti dietro la facciata tech. Il lavoro umano non cede il passo al digitale, ma resta nascosto dall’interfaccia tecnologica. Diventando invisibile e non sollevando più preoccupazione sociale. Nel mezzo della perturbazione tecnologica l’unico lavoro che rischia di sparire è quello di qualità», ragiona De Stefano, già docente all’Università Bocconi di Milano.
Il lavoro a cottimo del terzo millennio, in cui domanda e offerta s‘incrociano online, vale mille miliardi di dollari e il 5% del PIL degli Stati Uniti d‘America. Dove ormai i lavoratori freelance indipendenti sono 57 milioni, pari al 35% della forza lavoro. E in Italia? Secondo l’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), l’economia dei lavoretti impiega non più del 2,5% della forza lavoro italiana, pari a 590 mila lavoratori. Dal Belpaese emerge però una vera e propria questione salariale: in Italia i fattorini del cibo guadagnano in media 4 euro lordi a consegna. In Svezia e in Francia, dove la remunerazione è oraria, il compenso tocca rispettivamente i 13 e gli 11 euro l’ora.
«Il lavoro tramite piattaforma è solo uno specchio della qualità del resto del mercato del lavoro. Nei Paesi dove il resto del lavoro è ben protetto e pagato, il lavoro su piattaforma viene meglio incluso nella protezione. Nei Paesi nordici è regolato dalla contrattazione collettiva e protetto sindacalmente. In Germania si pensa di includere nella contrattazione collettiva addirittura i lavoratori su piattaforma virtuale. Un dibattito lontano anni luce dall’Italia. Qui sono quasi quarant‘anni che ammettiamo lavori autonomi che non hanno nulla di indipendente: finte partite IVA, co.co.co. senza alcuna autonomia, cooperative fraudolente. Le cattive condizioni dei lavoratori su piattaforma italiani sono il risultato di questo processo di precarizzazione e scarsa risposta protettiva generale», dice Aloisi, già Max Weber Fellow all’Istituto Universitario Europeo di Firenze e ricercatore alla Saint Louis University negli Stati Uniti.
A chi appartengono i lavoratori della Gig economy? È il principale, storico motivo di disputa tra piattaforme e lavoratori. Dipendenti o lavoratori a chiamata: qual è l’inquadramento contrattuale opportuno? Le sentenze della magistratura nel mondo restituiscono una matassa difficile da dipanare, che però sembra convergere in un’unica direzione. Nel dicembre 2018 la Corte Suprema del Regno Unito ha espresso un parere definitivo dichiarando due autisti Uber dipendenti della società. Nel settembre 2019 il governatore della California Gavin Newsom ha approvato un disegno di legge che impone alle società della gig economy di riqualificare i lavoratori a contratto in dipendenti.
Nel 2021 il governo spagnolo ha annunciato un accordo con i sindacati e le associazioni imprenditoriali che definisce i corrieri delle piattaforme di consegna Glovo con sede a Barcellona come dipendenti. La Corte Suprema del Regno Unito ha stabilito che i conducenti di Uber sono dipendenti. Ma è l’Italia che, secondo il Financial Times, guida la protesta in Europa dopo lo sciopero dei lavoratori di Amazon il 22 marzo 2021 e dopo la protesta dei riders delle piattaforme di consegna del cibo Just Eat il 26 marzo che ha portato a siglare il 29 marzo 2021 il primo accordo sindacale a livello nazionale tra sindacati e Just Eat Take Away Express che riconosce i riders come lavoratori subordinati e cha da ora in poi potranno godere di ferie, malattia, contributi, permessi, mensilità aggiuntive, paga oraria, maggiorazioni, Tfr.
«Secondo la Corte di Giustizia Europea non si può parlare di semplici intermediari quando piattaforme come Uber, Glovo o Deliveroo selezionano il personale, decidono quanto pagarlo, dettano standard di comportamento come guidare determinate macchine e indossare indumenti specifici, stabiliscono e controllano i tempi con cui il lavoro viene svolto, sanzionano i lavoratori se sforano questi tempi o se i consumatori non sono contenti», aggiunge De Stefano. «Dal potere di intrusione della piattaforma nelle modalità di erogazione del servizio consegue la necessità di assumersi le relative responsabilità. Tuttavia non è possibile dare una risposta valida sempre per tutte le piattaforme e i lavoratori. È possibile che ci siano lavori su piattaforma genuinamente autonomi, ma molto spesso questo non è il caso».
Le parti sociali e le forze politiche riusciranno a giocare un ruolo nella trasformazione in atto? «È necessario assumere i lavoratori delle piattaforme alla luce dei fabbisogni, assegnare loro dei turni, l’accesso alle richieste meglio pagate e la possibilità di contestare atteggiamenti capricciosi dei clienti. Occorre ripensare i modelli di sussidi al reddito, ma anche introdurre un codice di condotta per gli operatori digitali sul modello tedesco, per disciplinare i livelli minimi di pagamento da parte delle piattaforme. Bisogna evitare in tutti i modi un futuro del lavoro a guida autonoma» sottolinea De Stefano.