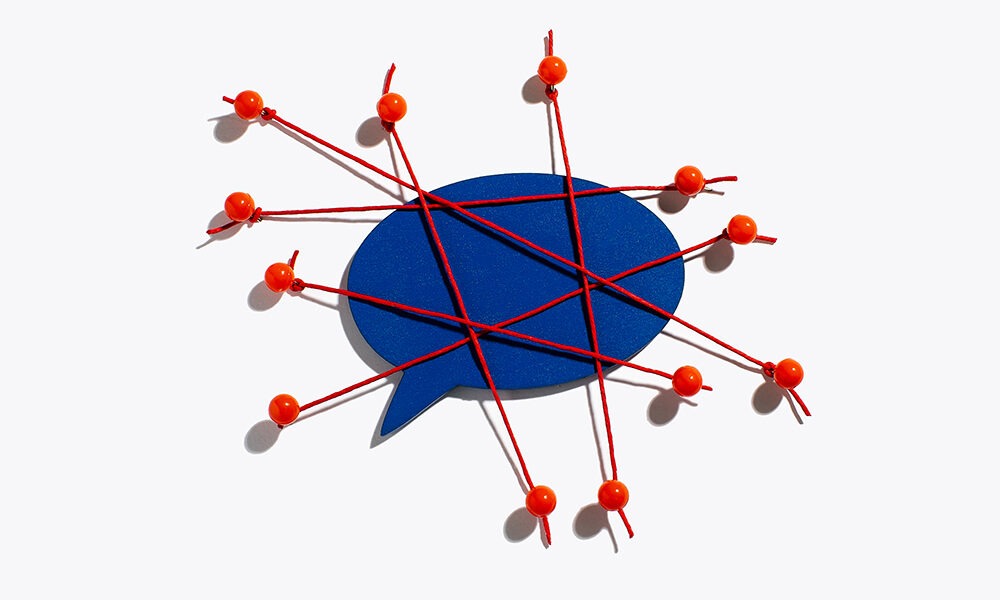Giustizia climatica: il clima è anche una questione di diritti
Negli ultimi anni, il cambiamento climatico non è più percepito soltanto come una crisi ambientale,ma come una vera e propria questione di giustizia. A pagare il prezzo più alto
Uno, nessuno e centomila, ci si potrebbe ispirare al titolo del celebre romanzo di Luigi Pirandello per dire dei volti che può assumere il fenomeno del greenwashing. Così non comunicare diventa la forma più sottile per aggirare il problema.
Sono davvero un’infinità i modi per “lavare” l’immagine del proprio business per provare a renderla, e soprattutto a farla percepire, migliore di quello che è. La tecnica dietro a operazioni di greenwashing è più o meno sempre la stessa: “martellare” a colpi di comunicazione. Così da associare l’immagine del business a una serie di fattori che si sa godono di una percezione positiva nell’opinione pubblica, anche se magari hanno poco o nulla a che vedere col core business, al fine di guadagnarne in reputazione. Allo stesso tempo, si cerca di allontanare lo sguardo del pubblico dagli impatti sociali e ambientali negativi del business, di cui è meglio non si sappia e non si parli troppo: “sopire, troncare”, insomma, per dirla col Manzoni de I Promessi Sposi restando in metafora letteraria. C’è però una nuova forma di greenwashing che si è affermata negli ultimi anni dove, al contrario di quelle tradizionali, conta quello che non si comunica, che si nasconde, si mette a tacere, si censura.
L’ultimo grido o, se si vuole, l’ultima mutazione del fenomeno greenwashing si chiama “greenhushing”: è la pratica, appunto, con cui le imprese, invece di affannarsi a urlare ai quattro venti quanto sono buone, brave e performanti – come hanno fatto sostanzialmente negli ultimi anni, da quando la sostenibilità è passata da nice-to-have a must-have -, cercano di nascondere o sottostimare risultati, impatti, progressi, obiettivi green. Di dire al massimo, in ottica di disclosure, quanto richiesto da leggi, regolamenti, standard. Senza però usare il megafono della comunicazione a supporto.
Già a fine 2022 il tema del greenhushing aveva attirato l’interesse del WEF, il World Economic Forum, sul cui sito se ne ragionava sulla base di un report pubblicato da South Pole che si può considerare forse il primo ad aver rivelato al grande pubblico che il greenhushing stava arrivando. L’attenzione sul tema su scala mondiale è poi ulteriormente cresciuta quando a occuparsene sono state testate come il Washington Post, il New York Times o il Wall Street Journal.
Il report di South Pole si focalizzava sugli impegni delle imprese in materia di obiettivi net zero (emissioni nette zero di gas serra): di certo non un caso, poiché è proprio questo uno degli ambiti nei quali il tradizionale greenwashing è dilagato. Al punto che le stesse Nazioni Unite si sono sentite in qualche modo “costrette” a costituire un team di esperti che ha definito delle Linee guida sui commitment net zero delle imprese diventate un punto di riferimento internazionale: già il titolo del documento (“Integrity matters”) era più che esplicito sulla grande confusione regnante in materia. Il report aveva analizzato gli impegni di oltre 1.200 imprese internazionali, tra l’altro scelte fra quelle considerate più sensibili ai temi ambientali. Evidenziando come circa un quarto di esse non offriva informazioni sui target di riduzione delle emissioni che si era data. Una stranezza, insomma. Che è addirittura aumentata in report successivi prodotti sempre da South Pole, che rivelavano come la tendenza a ridurre le proprie comunicazioni fosse generalizzata e interessasse ormai la maggioranza delle aziende indagate: sceglievano intenzionalmente di non dare conto di strategie e obiettivi climatici, di ridurre se non addirittura interrompere la comunicazione al riguardo.
Un report del 2023 di Planet Tracker ha invece inserito il discorso sul greenhushing nel contesto di una più ampia panoramica sul complessivo fenomeno del greenwashing. Fenomeno che, per via delle forme sempre diverse e sempre più sofisticate (fra le quali appunto il greenhushing) in cui si manifesta, veniva paragonato alla mitologica Idra dalle mille teste. In Italia un report di Fondazione Symbola e Unioncamere del 2020 stimava che circa il 40% delle imprese italiane avesse fatto greenhushing. Più recentemente, il Transparency Index 2024 ha evidenziato che il greenhushing è presente nella comunicazione di sostenibilità di quasi il 60% delle maggiori imprese britanniche e statunitensi.
Di greenhushing sono state tacciate negli anni aziende grandi e famose. In più di un caso, per giunta, si trattava di aziende che proprio a colpi di comunicazione avevano a lungo cercato di farsi percepire come leader nell’ambito della sostenibilità e dell’impegno sull’ambiente. Un’assurdità, dunque, o quanto meno una contraddizione? Così parrebbe a un esame superficiale. Ma basta scavare un po’ per far emergere le ragioni di questo nuovo modo di fare washing. Che non è né assurdo, né contraddittorio.
La motivazione principale, infatti, è quella di evitare di essere messi nel mirino da consumatori, investitori, regolatori o, ancor più, di essere oggetto di iniziative legali. Per cui si comunica di meno, con meno enfasi, rinunciando ad esempio a dichiarare obiettivi troppo ottimistici. Poi, con regolamenti e normative sulla comunicazione della sostenibilità che specie in Europa aumentano, si fanno più stringenti e inoltre subiscono un’evoluzione continua, peraltro dipendente dal colore politico dei policy-makers di turno, c’è il timore di essere colti in fallo da regolatori sempre più occhiuti. Ancora, c’è persino il rischio di venir risucchiati nel gorgo dello scontro politico – scoppiato negli Stati Uniti ma arrivato poi rapidamente anche in Europa – tra fautori e oppositori della transizione, dell’abbandono dei combustibili fossili, della regolamentazione sui temi Esg.
In parte sono motivazioni plausibili, anche se bisogna vedere se chi le cavalca è in buona fede. Ma il punto è che il fenomeno greenhushing, se dovesse espandersi ancora, potrebbe produrre effetti estremamente pericolosi, per tutti. C’è soprattutto il rischio che si inneschi una corsa al ribasso, a una crescente mancanza di trasparenza su performance di sostenibilità e strategie di contrasto alla crisi climatica. Se non comunicano adeguatamente i big – è il ragionamento che potrebbe prender piede – e le aziende che fino all’altro ieri si ritenevano all’avanguardia su questi temi, perché devono farlo le imprese per così dire normali? Inoltre, per consumatori e investitori potrebbe diventare sempre più difficile valutare effettivamente la sostenibilità di un’impresa o di un prodotto, capire cioè quali garanzie di sostenibilità offrono. La pressione generale sui temi di sostenibilità, quindi, potrebbe scemare. E potrebbe ulteriormente rallentare la transizione, che già va molto a rilento.
Difficile dire ora se il greenhushing sia destinato a durare. C’è chi crede, o forse si augura, che rendere obbligatoria la rendicontazione di certi dati e informazioni, come sta facendo in Europa la direttiva CSRD, potrebbe spazzare il campo da questi problemi. Ma, lasciando stare il fatto che la stessa CSRD si sta scontrando con forze molto potenti che cercano di ostacolarne la messa a terra effettiva, come abbiamo visto il greenhushing si è sviluppato in parte proprio come reazione a una normativa che, almeno in certi ambienti, è stata percepita come eccessivamente invasiva e onerosa. Per cui è tutto da vedere se una delle cause del problema potrà diventarne la soluzione. Sembra il classico circolo vizioso. Ed è davvero il caso di domandarsi: come se ne esce?