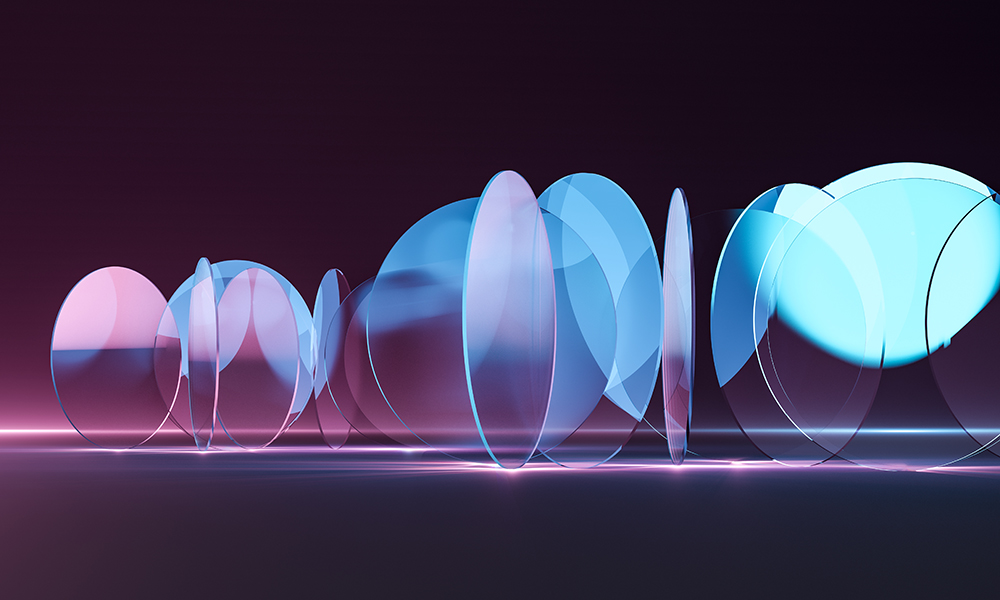L’intelligenza artificiale aumenterà o distruggerà l’occupazione?
Risponde l’Intelligenza Artificiale Con l’avanzare dell’intelligenza artificiale, il lavoro umano cambierà profondamente: verranno creati più posti di quanti ne perderemo,
Un viaggio brillante tra psicologia, marketing e comportamenti umani: Rory Sutherland ci mostra come l’irrazionalità possa essere una risorsa creativa, ma solo se la leggiamo con due lenti, quella della fantasia e quella dell’analisi.
Alchemy di Rory Sutherland è un libro brillante, pieno di trovate, scritto con la verve di chi la pubblicità non la studia: la vive. La sua tesi è semplice e accattivante: gli esseri umani decidono raramente secondo una “logica” pulita; ragionano per scorciatoie, contesto, emozioni, status, simboli. Sutherland chiama questo modo di ragionare “psycho-logic”, per distinguerlo dalla razionalità da manuale, e invita chi progetta prodotti, politiche o messaggi a prenderla sul serio.
Il libro funziona benissimo quando mostra, con aneddoti e battute folgoranti, che molte soluzioni controintuitive meritano un test proprio perché sfuggono alle griglie dei fogli Excel. “Se ci fosse una risposta logica, l’avremmo già trovata”, scrive Sutherland, ricordando che l’opposto di una buona idea può essere, a volte, un’altra buona idea. Il messaggio è: uscite dal binario unico del “cosa è razionale?” e chiedetevi anche “cosa funziona davvero?”.
C’è pure il piacere della lettura: è pieno di note e note a piè di pagina, spesso spassose, che in edizione cartacea si gustano meglio. È il Sutherland migliore: quello capace di trasformare un esempio di naming (“Bob”, il guidatore sobrio) o di framing in una piccola lezione di psicologia applicata, senza fare la morale e con il gusto del paradosso.
Detto questo, Alchemy non è, e non pretende davvero di essere, un trattato di economia comportamentale. È soprattutto un inno al marketing, raccontato come arte oscura capace di miracoli quotidiani; “un fiore è solo un’erbaccia con un budget pubblicitario”, scherza l’autore, e il tono è proprio questo: sfrontato, teatrale, seducente. Il rischio, però, è che l’arte diventi teologia e che il marketing appaia come una bacchetta magica, mentre la realtà è più testarda.
Il punto cieco sta nella binarizzazione razionalità/irrazionalità. È una dicotomia comoda per fare storytelling, ma è diventata una caricatura accademica: oggi la cassetta degli attrezzi della microeconomia integra stabilmente risultati e metodi della behavioral. I modelli “standard” non sono nemici: offrono un linguaggio comune, ipotesi chiare, una metrica per capire dove e quando gli scarti psicologici contano. Senza quel riferimento, anche gli esperimenti più creativi perdono la bussola: non sappiamo se abbiamo scoperto un effetto o solo raccontato bene un aneddoto.
Per leggere Alchemy al meglio, serve una metafora cornice: gli occhiali bifocali. Con la lente “lunga” (i modelli, il pensiero lento, la razionalità olimpica) metti a fuoco la struttura del problema: vincoli, incentivi, equilibrio. Con la lente “corta” (la psycho-logic di Sutherland) cogli le distorsioni utili: contesto, norme sociali, segnali di status, estetica, linguaggio. Solo con entrambe le lenti vedi nitido. Se usi solo quella corta, tutto sembra magia e rischi di scambiare l’eccezione per regola; se usi solo quella lunga, perdi le occasioni che nascono dal “non-senso che funziona”.
Qui Sutherland esagera per scelta retorica. Attacca la “logica riduzionista” perché vuole liberare budget per soluzioni improbabili, e la sua è una difesa salutare dell’esplorazione: sperimentate anche ciò che non ha una giustificazione elegante, fallite un po’ più spesso, non progettate per la media. Ma l’antidoto non è abolire la richiesta di ragioni: è alternare esplorazione e valutazione, creatività e controllo, ipotesi audaci e misure robuste. È esattamente ciò che la buona economia comportamentale già fa quando connette teorie, dati e disegno sperimentale.
Il libro, insomma, è un ottimo acceleratore di intuizioni. Leggendolo si impara a diffidare della tirannia della media, del culto della metrica unica, dell’ossessione per la spiegazione ex-ante; si impara a riconoscere il potere di nomi, rituali, piccoli costi e piccoli doni. E si gode di un umorismo che, a tratti, taglia come un bisturi. Ma per trasformare l’intuizione in politica efficace o in prodotto migliore, serve la controparte più noiosa e fondamentale: l’analisi “lenta”, la modellizzazione che fa pulizia, la statistica che distingue l’idea brillante dalla coincidenza.
Due avvertenze per l’uso.
Verdetto? Alchemy è piacevolissimo, utile, pieno di scintille. Da tenere sul comodino insieme al manuale di microeconomia: con gli occhiali bifocali indosso, le sue magie diventano ipotesi da provare, non dogmi da ripetere. E la lezione che resta è la migliore: nella complessità umana, creatività e rigore non si escludono; si accordano, come due lenti che finalmente mettono a fuoco lo stesso mondo.