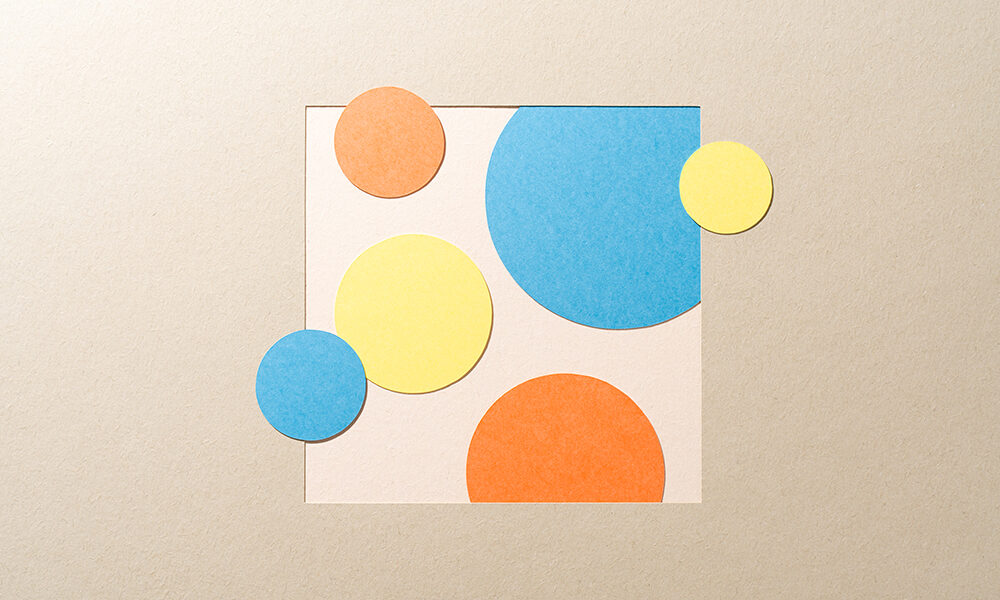Addio alla classe media
La classe media sta scomparendo. Insieme a essa anche le “marche medie” — quei brand che per decenni hanno sorretto i consumi occidentali — stanno perdendo peso e rilevanza
Sempre più frequentemente mi capita di imbattermi in un’espressione e domandarmi se si tratta di un ossimoro o di uno scorretto, o addirittura forzato, accostamento. E questo capita sempre più spesso quando c’è da dimostrare di essere inclusivi.
Da studente, avevo una memoria solidissima: di fronte a un testo letterario ero in grado di scovare le più strambe figure retoriche, attingendo con i miei ricordi agli angoli più reconditi del manuale scolastico. C’è, però, una figura retorica che non ho mai dovuto memorizzare; l’interesse che le rivolsi dal primo istante è stato risolutivo per imprimerla nei miei pensieri: l’ossimoro. Molti di voi lo ricorderanno: è quello strano procedimento che consiste nell’unire due parole o espressioni che sono inconciliabili nel significato, ma la cui contrapposizione viene superata dal loro accostamento. Un esempio: l’assordante silenzio. Quanta potenza dall’unione di due opposti!
Sempre più frequentemente mi capita di imbattermi in un’espressione e domandarmi se si tratta di un ossimoro o di uno scorretto – o addirittura forzato – accostamento: il «lusso inclusivo». Il lusso è per definizione esclusivo: compete solo alcuni, escludendo altri da una sua fruizione; è cioè riservato a pochi privilegiati; punta sulla rarità, a discapito dell’accessibilità.
La prima impressione è quella di trovarsi di fronte a un surrogato del greenwashing: in questo caso, una strategia per presentare sotto una facciata di inclusività beni ed esperienze che non lo sono affatto. È in questa ottica che spesso ho letto le collaborazioni tra i marchi di fast fashion e i luxury brand: capsule collection accessibili che danno l’illusione (ma non di certo la sostanza) di esclusività. Lo stesso vale per la tendenza di numerosi chef stellati di dar vita a pasticcerie, panifici, locali street food di qualità senz’altro eccellente. L’offerta è accessibile, ma non prevede alcun accesso al lusso di un menù degustazione che offre un’esperienza estetica, oltre che gastronomica, con annessi effetti scenografici e memorie indelebili.
Forse però per comprendere questo strano accostamento tra «lusso» e «inclusività» e scoprire se si tratta davvero di un ossimoro vincente è necessario interrogarsi sull’attuale evoluzione dei termini connessi alla tematica; e, eventualmente, invertire l’intero paradigma.
Oggi, in un mondo in cui il rispecchiamento dell’identità rappresenta una delle prime scelte d’acquisto, il significato della parola «esclusività» sta cambiando: non dipende più dall’esclusione e, dunque, dal costo, ma dal grado di identificazione con i valori espressi da quel bene.
Soprattutto per le nuove generazioni, un bene è esclusivo non (anzi, ammettiamolo, senza retoriche, non solo) per il brand, ma anche per il rispetto di una rinnovata idea di lusso: la sostenibilità ambientale; i diritti di genere; l’impegno sociale; il body positivity, e così via.
Persino la mitologia di un marchio, fino a pochi anni fa inattaccabile, non è più sufficiente per rappresentare uno stile di vita percepito come «lusso». In altre parole, l’appartenenza a un’élite non si gioca più e non solo sul campo socioeconomico, quanto su quello della condivisione dei valori.
Dunque, oggi il «lusso inclusivo» è un riuscitissimo ossimoro. Anche questa volta, i ricordi del mio manuale di analisi retorica mi hanno aiutato.