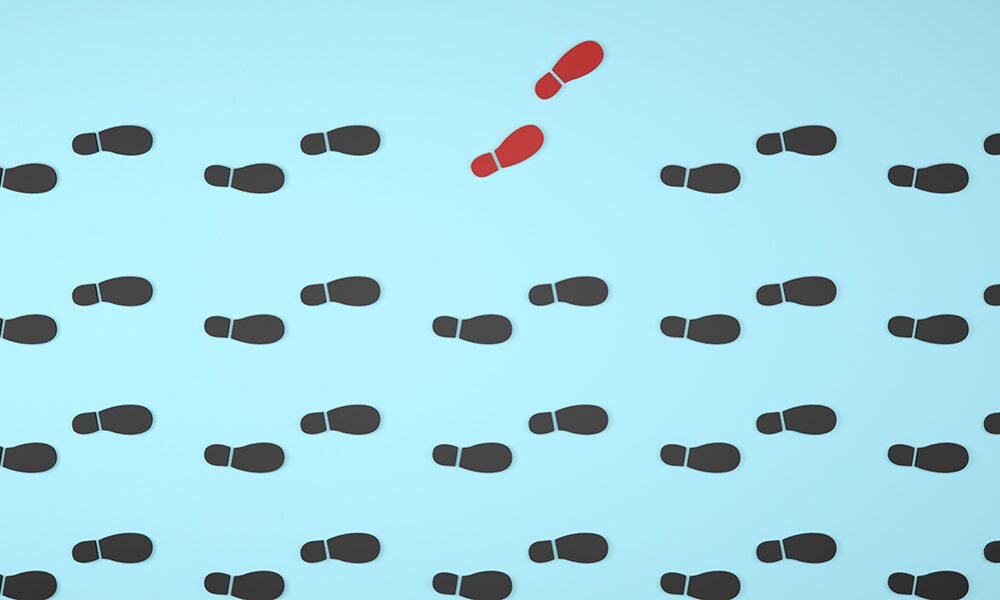La geopolitica del genio: quando il talento diventa potere
Chi rifiuterebbe un’offerta di lavoro da 125 milioni di dollari? Matt Deitke, talento ventiquattrenne dell’intelligenza artificiale, l’ha fatto. Solo per accettarne una doppi
Come rispondere alla domanda seguendo l’esempio di Scott Galloway, imprenditore e docente, e Mihály Csíkszentmihályi, psicologo ungherese.
La scelta tra talento e passione è uno dei dilemmi più ricorrenti nella vita personale e professionale. Cosa conta di più per trovare la realizzazione: avere talento naturale in un ambito oppure seguire una passione anche se non si eccelle fin da subito? Due visioni contrapposte aiutano a riflettere su questa domanda: quella dell’imprenditore e docente Scott Galloway e quella dello psicologo ungherese Mihály Csíkszentmihályi.
“È più importante il talento o la passione?”. Una domanda semplice solo in apparenza, che nasconde un forte carico emotivo ed esistenziale. Alcuni fortunati riescono a unire talento e passione, ma per la maggior parte delle persone il percorso è più accidentato. Capita spesso di voler fare qualcosa in cui non si è portati, oppure di eccellere in un ambito che non entusiasma. Come orientarsi allora?
Forse la domanda può essere riformulata, come farebbe un bambino: «È più importante il talento o la passione?». Per provare a rispondere, analizziamo le visioni di due figure autorevoli.
Secondo Scott Galloway, autore del bestseller The Four – I padroni, la risposta è netta: vince il talento. Per lui, seguire la propria passione è un consiglio riservato ai privilegiati. La vera chiave del successo è identificare in fretta in cosa si è bravi, migliorare con impegno costante e raggiungere l’eccellenza. Il riconoscimento e i risultati ottenuti porteranno poi ad apprezzare l’attività, anche se inizialmente non era una passione.
«Le persone che vi consigliano di seguire la vostra passione sono già ricche. Non seguite la passione, seguite il talento. Scoprite presto in cosa siete bravi e impegnatevi per eccellere. Se la pratica vi farà diventare bravissimi, il riconoscimento e i compensi che riceverete vi faranno amare quell’attività» – Scott Galloway
La sua visione riflette anche un certo spirito culturale: Galloway è americano e incarna l’etica del lavoro e del successo, dove “volere è potere” e dove puntare alla carriera prima della vita privata è spesso la norma.
Scavando nella sua biografia e tra le sue interviste, risulta lampante come Scott abbia lottato tutta la vita con i denti su qualsiasi obiettivo raggiunto, piccolo o grande che fosse. È statunitense fino al midollo, immerso in una cultura in cui dimostrare il proprio valore significa avere successo. «Oggi ho un buon equilibrio» afferma Scott «perché non l’ho avuto a venti e a trent’anni. A parte la business school, dai ventidue ai trentaquattro ricordo di aver lavorato e fatto poco altro. Il mondo non appartiene ai grandi, ma ai veloci. Dovete puntare ad arrivare più lontano degli altri in meno tempo. Il mio mancato equilibrio quand’ero un giovane professionista mi è costato i capelli, il primo matrimonio e probabilmente il decennio dai venti ai trenta. E ne è valsa la pena».
Dall’altra parte, Mihály Csíkszentmihályi sostiene con forza l’importanza della passione autentica. Nel suo libro Flow, spiega come l’esperienza del “flusso” – uno stato di pieno coinvolgimento e piacere nell’attività – sia fondamentale per la felicita e la realizzazione.
Ricorda che i termini “amatore” e “dilettante”, oggi spesso usati con disprezzo, in origine indicavano chi amava ciò che faceva. «Oggi queste etichette sono sottilmente spregiative» spiega Mihály «ma in origine ‘amatore’, dal verbo latino amare, indicava una persona che amava quel che faceva. Analogamente un ‘dilettante’, dal latino delectare, era qualcuno che provava molta soddisfazione in una data attività».
Anche Csíkszentmihályi ha vissuto negli Stati Uniti, dove emigrò a 22 anni, ma trascorse lunghi periodi anche in Italia, un Paese che amava profondamente. La sua visione riflette un’influenza più mediterranea, più attenta al godimento dell’esperienza che alla corsa verso il successo. In Italia, si sa, è più frequente sentirsi dire che “godere è dovere”.
Le opinioni di Galloway e Csíkszentmihályi sono figlie di contesti culturali diversi. Il primo rappresenta una visione americana, orientata al risultato e alla performance. Il secondo riflette influenze più umanistiche, dove il piacere dell’esperienza ha valore intrinseco.
Uno studio condotto nel 1987 da Eugene Griessman supporta la visione di Csíkszentmihályi. Intervistando persone di successo in diversi settori, emerse che la caratteristica più importante per raggiungere risultati straordinari era il benessere provato nello svolgere la propria attività (punteggio medio: 9,86 su 10). Insomma, senza avere passione, difficilmente si diventa fuoriclasse.
Molti scienziati premiati con il Nobel raccontano il loro lavoro come un gioco affascinante. Come Albert A. Michelson, primo statunitense a vincere il Nobel per le scienze, che dichiarò: «Misurare la velocità della luce? Era molto divertente».
Da queste riflessioni emergono due considerazioni. La prima: se capite che nella vostra vocazione è prioritaria la ricerca di esperienze appassionanti, inseguite le vostre passioni. La seconda: se ambite a un grande successo, inseguite comunque una passione in cui potete eccellere. In entrambi i casi, la passione è decisiva.
Dunque, è più importante avere talento o avere passione? La risposta non è univoca e dipende dalla propria indole. C’è chi trae soddisfazione nel eccellere grazie al proprio talento, e chi trova la propria strada seguendo una passione, anche senza garanzie di successo.
Ma attenzione: talento e passione non sono opposti, possono convivere e rafforzarsi a vicenda. La vera realizzazione spesso arriva quando la passione incontra il talento, in un mix potente che unisce competenza e coinvolgimento emotivo. Non si tratta di scegliere, ma di scoprire il proprio equilibrio.
Come ricorda una celebre frase tratta da “Inno alla vita” di Charlie Chaplin:
«Ama ciò che fai, e farai ciò che ami».
Alla fine, forse non serve scegliere per forza. A volte, è più che una passione. È una vocazione.
*Articolo pubblicato il 14 marzo 2022 e sottoposto a successive revisioni