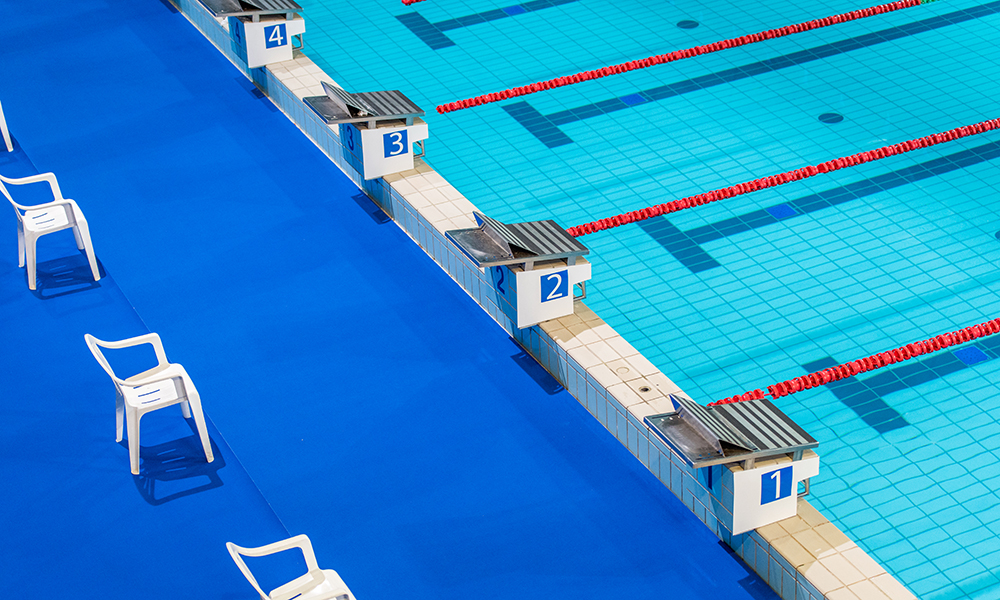Addio alla classe media
La classe media sta scomparendo. Insieme a essa anche le “marche medie” — quei brand che per decenni hanno sorretto i consumi occidentali — stanno perdendo peso e rilevanza
Dalla pallavolo all'atletica, fino al tennis e al pugilato, gli sportivi di seconda generazione stanno dimostrando che l'integrazione è una realtà. Almeno sul campo.
Corrono, saltano, marciano, nuotano, schiacciano, tirano pugni. Hanno accenti veneti, lombardi, siciliani, toscani. Hanno le radici in Paesi diversi del mondo e provengono da storie diverse. Sono gli atleti e le atlete che stanno cambiando il volto dello sport italiano, rendendolo non solo ancora più vincente ma anche – era ora – in sintonia con i tempi. Li chiamano “di seconda generazione”, qualifica che non vale per tutti (ci sono anche i naturalizzati) ma è sicuramente meglio di altre definizioni che si portano dietro un retaggio a volte inconsapevolmente razzista.
Come ha dichiarato in una intervista Sara Curtis, la nuova grande speranza del nuoto femminile nata nel 2006 a Savigliano da padre italiano e madre nigeriana: «Sono la prima campionessa di nuoto italiana nera, anzi mulatta. Non mi piace quando sento dire “di colore”, non ha senso, a parte che anche il bianco è un colore e poi nessuna pelle al mondo è davvero bianca».
Curtis ha perfettamente ragione. In altri Paesi il colore della pelle – nello sport, almeno – è qualcosa di cui non si accorge pressoché nessuno, anche per lunghe storie di immigrazione e (meno onorevolmente) di colonialismo. Nel nostro, invece, una grande pallavolista come Paola Egonu (genitori nigeriani, campionessa olimpica a Parigi 2024 come la sua compagna di squadra Miriam Sylla, nata a Palermo da famiglia ivoriana) deve ancora fare la fatica di rispondere a chi, grottescamente, ne chiama in causa i «tratti somatici diversi dalla maggioranza degli italiani».
Sì, qualcosa è cambiato. E all’avanguardia di questa trasformazione – peraltro assolutamente naturale e prevedibile anche dal punto di vista della statistica – c’è soprattutto l’atletica. Agli ultimi mondiali indoor di Nanchino Mattia Furlani e Andy Diaz hanno vinto la medaglia d’oro rispettivamente nel salto in lungo e in quello triplo, così come entrambi erano riusciti a tornare a casa da Parigi l’anno scorso con un bronzo. Diaz è cubano naturalizzato italiano, Furlani è figlio d’arte (anzi di sport): il padre Marcello è un ex azzurro di salto in alto, la madre Kathy Seck, senegalese, è stata velocista e oggi allena il figlio.
Storia simile, sempre nel salto in lungo ma femminile, a quella di Larissa Iapichino, erede in tutti i sensi della grande Fiona May (anche se è allenata dal padre, Gianni). Sempre a Nanchino c’è stato l’argento nei 60 metri piani di Zaynab Dosso, nata in Costa d’Avorio e ricongiuntasi nel 2009 con i genitori emigrati in Emilia sette anni prima.
Visto che si parla di medaglie, come dimenticare l’impresa della 4×100 maschile a Pechino nel 2021? Due su quattro dei nostri velocisti avevano la pelle scura: la star Marcell Jacobs (campione olimpico anche nei 100, papà texano ma cresciuto con la mamma a Desenzano) e Faustino Desalu, nato in provincia di Cremona da famiglia nigeriana.
L’elenco sarebbe ancora lunghissimo, ci limitiamo a citare tra chi già ha ottenuto grandi risultati la splendida mezzofondista, di origini marocchine da parte di madre, Nadia Battocletti (capace nel solo 2024 di diventare due volte campionessa europea e vice-campionessa olimpica), il velocista Chituru Ali (metà ghanese, metà nigeriano e interamente italiano), il maratoneta Yeman Crippa (etiope adottato da famiglia trentina), l’ostacolista Lorenzo Ndele Simonelli (madre tanzaniana conosciuta dal padre antropologo in Africa).
Paradossalmente (o forse no) lo sport più indietro da questo punto di vista è quello più ricco e popolare: il calcio. Sono ancora pochissimi i “nuovi italiani” nelle squadre peraltro infarcite di stranieri. I Balotelli e più recentemente gli Udogie rappresentano eccezioni e non la regola. Le ragioni? In parte l’endemico conservatorismo del mondo del pallone, ma soprattutto le strategie miopi di società che preferiscono fare plusvalenze su calciatori provenienti da ogni parte del mondo piuttosto che curare vivai di ragazzi italiani, di qualunque origine siano.
In conclusione, la nuova generazione dello sport italiano è caratterizzata da una straordinaria varietà che arricchisce il panorama sportivo del Paese. Questi atleti rappresentano il futuro e il cambiamento, impegnandosi non solo a vincere, ma anche a trasformare la cultura sportiva italiana, rendendola più inclusiva e rappresentativa della società che li ha generati.