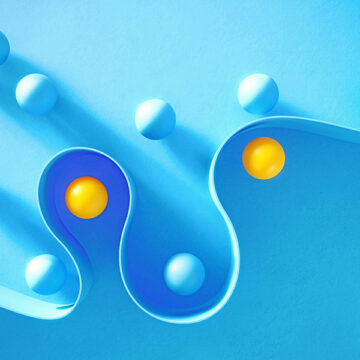Le città hanno avuto da sempre un ruolo fondamentale per il commercio al dettaglio. Nel mondo Post-Covid i brand e i retailer dovranno ridurre drasticamente la presenza fisica. Come può cambiare il modello di vendita.
Già nella storia antica e poi sempre di più nel corso degli ultimi due secoli, le città hanno avuto un ruolo determinante nell’evoluzione del commercio a dettaglio ( e quindi dei negozi). Dai bazar dei tempi antichi, ai grandi e opulenti magazzini del ‘800 fino alla nascita delle start-up dell’e-commerce dei primi anni 2000, le città hanno offerto ai brand e ai retailer sia il palcoscenico che il pubblico, e ne hanno anche determinato il successo finanziario che ha poi alimentato il loro sviluppo.
Il Covid-19 potrebbe sconvolgere tutto questo. Nei prossimi anni, nelle principali economie del mondo, si potrebbe infatti assistere ad una migrazione al contrario rispetto a quella sperimentata a partire dagli anni ’50. Le grandi aziende stanno infatti ripensando la posizione fisica dei loro dipendenti, incoraggiandoli a vivere e lavorare dove essi preferiscono. Verrebbe cioè abbandonata la cosiddetta office centricity, uno dei paradigmi che negli ultimi decenni ha governato tutte le aziende del mondo cosiddetto “moderno”.
Vediamo meglio, attraverso alcuni esempi, cosa è successo dall’inizio della pandemia. Per prima è arrivata la decisione del colosso bancario inglese Barclays, che durante il lockdown dello scorso anno ha fatto lavorare da casa circa 70.000 persone. Il 29 Aprile 2020 James Staley – ceo di Barklays – dichiarò infatti, «Ci sarà un aggiustamento a lungo termine nel modo in cui pensiamo alla nostra strategia di localizzazione … l’idea di mettere 7.000 persone in un edificio potrebbe essere un ricordo del passato». Non male per iniziare ad abbandonare la cultura della office centricity. A metà maggio 2020 è arrivato poi Jack Dorsey – CEO di Twitter – il quale inviò una mail a tutti i dipendenti dell’azienda per comunicare loro la possibilità di continuare a lavorare da casa, per sempre. Non si trattava di una decisione inattesa. Infatti, già all’inizio di marzo, Jennifer Christie, Head of HR di Twitter, aveva dichiarato: «La nostra azienda probabilmente non sarà più la stessa nella struttura del suo lavoro. Le persone che erano reticenti a lavorare in remoto scopriranno che si può fare … I manager che non pensavano di poter gestire team da remoto lavoreranno con una prospettiva diversa. Penso che non torneremo indietro».
Si è arrivati poi al 21 maggio 2020, giorno in cui il fondatore e ceo di Facebook, Mark Zuckerberg, dichiarava a The Verge: «Saremo l’azienda più orientata al lavoro a distanza nel futuro … Dobbiamo farlo e lo faremo in modo misurato. Ma penso che sia possibile che nei prossimi cinque o dieci anni potremmo arrivare a circa la metà dell’azienda che lavora da remoto in modo permanente». Per spiegare meglio l’entità del cambiamento annunciato da Zuckerberg, evidenzio che Facebook fino a poco tempo prima offriva ai neoassunti un bonus per prendere casa vicino alla sede centrale di Menlo Park. Il bonus aveva un valore che poteva arrivare fino a 15.000 dollari. Ora invece – dopo l’annuncio del 21 maggio dello scorso anno – è come se consentisse ai dipendenti di far ruotare il mappamondo con un dito e indicare dove si vorrebbe che fosse collocata la propria casa, in cui vivere e ovviamente lavorare.
Il boom dello smartworking
Per quanto riguarda l’Italia, riporto alcuni dati dell’Osservatorio del Politecnico di Milano sullo Smart Working. Nel 2019, prima che l’esperienza Covid-19 sconvolgesse il modo di vivere e lavorare, lo smart working riguardava 570.000 lavoratori, il 20% in più dell’anno precedente. L’emergenza Covid-19 ha poi avuto un impatto travolgente: il numero di lavoratori “da remoto” è improvvisamente schizzato a oltre 6,5 milioni. Al termine dell’emergenza, l’Osservatorio del Politecnico di Milano stima che i lavoratori agili saranno complessivamente 5,35 milioni, con un numero medio di giornate lavorate da remoto che passerà da 1 a 2,7 giorni a settimana.
È chiaro che molte delle persone che oggi abitano nelle grandi città, con la possibilità di lavorare da remoto, potranno decidere di abbandonare le loro abitazioni cittadine. Si tratta ovviamente di mie ipotesi personali, che però trovano conforto ad esempio in una recente ricerca commissionata da Citrix a CensusWide su un campione di 3700 dirigenti di aziende IT dislocati in 7 paesi del mondo. La ricerca ha evidenziato che almeno 7 dipendenti su dieci vuole continuare a lavorare da casa. Questo dato conferma una survey del 2019 condotta nella Bay Area di San Francisco, in California. Su 4400 persone intervistate, il 66 per cento dichiarò che prenderebbe seriamente in considerazione di lasciare l’area di San Francisco se l’azienda consentisse loro di lavorare da remoto. E lascio a voi immaginare quanti sarebbero coloro che lascerebbero istantaneamente le nostre grandi città – in primis Milano e Roma – per andare a vivere in uno qualsiasi dei posti più belli al mondo presenti nella nostra penisola. E ovviamente tutto questo varrebbe anche per coloro che vivono e lavorano a Parigi piuttosto che a Londra.
Ed è anche facile prevedere che saranno soprattutto lavoratori con redditi medi e alti quelli che potrebbero lasciare le città e lavorare da remoto. I primi dati raccolti ad esempio per la città di New York, hanno evidenziato che nei primi undici mesi del 2020 la città ha subito un deflusso netto di 70.000 persone con una perdita di reddito su base annua pari a 34 miliardi di dollari. Questa perdita di reddito così elevata è stata provocata dal fatto che le famiglie che hanno lasciato la città vivevano nei quartieri centrali con un reddito medio annuo di 140.000 dollari, mentre quelle che sono entrate – prendendo casa nelle aree meno centrali della città – hanno un reddito medio di circa 80.000 dollari.
Gli effetti sui brand dei mercati consumer ed in generale sui retailer potranno quindi essere di una dimensione che definire “stellare” appare riduttivo. L’economia delle grandi città è stata infatti modellata attorno all’enorme flusso di persone con redditi medi e alti che si muove da e verso gli uffici, dai loro orari nell’utilizzo dei mezzi pubblici e privati, nonché dalle loro pause nel corso della settimana e ovviamente dei fine-settimana, in cui acquistare e consumare prodotti e servizi. Se questi flussi si modificheranno, riducendosi in modo drastico, allora molti dei ristoranti, bar e soprattutto negozi delle città, dovranno cessare la loro attività, o comunque modificarla radicalmente.
Se questo scenario viene combinato con le ultime previsioni relative al numero – fortemente crescente – di consumatori che utilizzerà il canale digitale per acquistare i prodotti di consumo, allora per i brand e per i retailer sorge spontanea una domanda: quanti negozi dovranno chiudere? Per poter rispondere a questa domanda, è chiaro che bisognerà rivedere completamente il modo in cui viene valutata la redditività dei negozi fisici. Se infatti un negozio sarà giudicato sulla base dei criteri dell’era Pre-Covid, cioè sulla base delle vendite totali o al metro quadrato piuttosto che sulla base di altri indici di produttività comunque direttamente discendenti dalle vendite del negozio, è chiaro che molti, moltissimi negozi, dovranno essere chiusi.
Si tratta però di criteri che raccontano una storia decisamente incompleta del valore e del contributo che un negozio può dare al conto economico di un’azienda. Per ovviare a questa incompletezza, alcuni brand ed alcuni retailer hanno iniziato ad attribuire ai negozi tutte o almeno una parte delle vendite online realizzate nelle aree circostanti ai negozi stessi. Si tratta di tentativi che si avvicinano di più al riconoscimento del reale valore di un negozio, ma che risultano ancora piuttosto approssimativi. Per questo motivo, nell’ultimo periodo diversi chief officers mi hanno chiesto di sviluppare una modalità più pertinente per calcolare il reale contributo che un negozio fisico dà – o potrebbe dare – al conto economico delle loro aziende.
Il valore dell’impressione fisica di un negozio
Poco tempo fa ero impegnato in una conversazione con i chief officers di una nota azienda del lusso, impegnati a ridisegnare completamente la presenza dei loro negozi nel mondo, colpita duramente dalla pandemia.
Ho chiesto loro quanti consumatori entrano mediamente in un negozio posizionato in una via centrale di una grande città europea o nordamericana oppure di una grande città asiatica. Per l’azienda in questione si tratta di diverse decine di migliaia all’anno. Complessivamente, in tutti i negozi di quell’azienda entrano circa 45 milioni di consumatori all’anno. A questo punto ho chiesto loro di stimare quale sarebbe il costo per “raggiungere” quei 45 milioni di consumatori all’anno – non attraverso un video di 15 secondi su Facebook o su YouTube, piuttosto che attraverso i post di una influencer su Instagram – ma attraverso una esperienza fisica multisensoriale prolungata, diciamo di circa 20 minuti, realizzata in modo tale che il consumatore possa realmente “toccare” il brand, comprenderne i prodotti e iniziare a sentirsi parte della comunità del brand.
La risposta che mi è stata data: sarebbe un costo gigantesco, totalmente al di fuori della portata anche del più grande acquirente di spazi pubblicitari al mondo. E questo è proprio il punto che deve essere messo a fuoco per misurare la reale redditività dei negozi fisici. Quell’azienda e i suoi brand – attraverso i propri negozi – sta infatti già “raggiungendo” i consumatori in una esperienza emotiva altamente coinvolgente. Quello che non sta facendo è misurarne il valore complessivo e il contributo di ogni singolo negozio.
In altre parole, se qualche decina di milioni di consumatori all’anno entrano in contatto con un brand visitando i suoi negozi e ricavandone una “impressione”, allora dovrebbe essere attribuita a quei negozi almeno un’approssimazione del valore di mercato di quei contatti fisici. È quello che io chiamo il “valore dell’impressione fisica“, qualcosa di simile alle impressioni digitali, quelle che i brand pagano per ingaggiare i consumatori nei punti di contatto digitali, quali ad esempio la visione di un video su Facebook piuttosto che YouTube, oppure i post di una influencer su Instagram.
Inoltre, se da una parte il panorama digitale è diventato estremamente affollato, e molti studi dimostrano l’estrema difficoltà nel misurare correttamente l’effetto causale dei media digitali sul comportamento d’acquisto dei consumatori, è invece certamente possibile misurare in modo piuttosto rigoroso l’effetto causale che deriva dall’esperienza fisica ed emozionale vissuta in un negozio.
A titolo illustrativo, ho potuto misurare per alcuni negozi in grado di far vivere esperienze emozionali molto positive, un valore dell’impressione fisica pari a circa 15 volte il costo di un contatto con un video in-stream su Facebook. Per un negozio situato in una via centrale di una grande città, questo equivale ad un valore delle impressioni fisiche compreso tra 1,5 e 4 milioni di euro. Tale valore si deve quindi aggiungere al valore delle vendite per ottenere il valore complessivo del negozio. Ci sono ovviamente anche casi in cui la valenza emozionale della visita in un negozio può essere negativa, ed in quel caso il valore dell’impressione fisica deve essere sottratto dalle vendite per ottenere il valore complessivo del negozio.
Nel mondo Post-Covid i brand e i retailer dovranno molto probabilmente ridurre drasticamente il numero dei negozi fisici. Se i negozi saranno valutati solamente sulla base delle vendite, il rischio sarà quello di decidere la chiusura dei negozi sbagliati. Ci sono negozi di piccole dimensioni che generano esperienze emozionali avvincenti e straordinarie per i consumatori e contribuiscono in questo modo a dare un contributo positivo al conto economico di un brand o di un retailer. Ci sono invece flagship store di grande dimensione, molto elaborati e costosi che generano invece esperienze emozionali negative e che determinano una enorme perdita di valore per il conto economico. Solo misurando il valore dell’impressione fisica che i consumatori vivono nel negozio sarà possibile capire il reale contributo che un negozio può dare al conto economico di un brand o di un retailer.