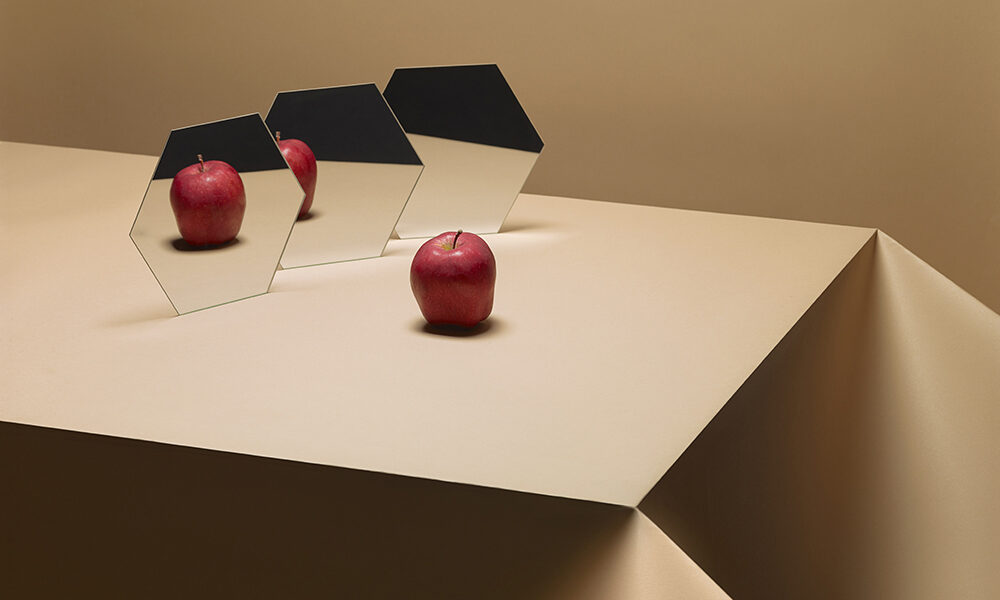La geopolitica del genio: quando il talento diventa potere
Chi rifiuterebbe un’offerta di lavoro da 125 milioni di dollari? Matt Deitke, talento ventiquattrenne dell’intelligenza artificiale, l’ha fatto. Solo per accettarne una doppi
Le conoscenze scientifiche moderne non derivano dagli sviluppi sociali, economici e politici dell’Occidente, ma sono causate da un improvviso rifiuto della filosofia come mezzo per la verità a favore della sola osservazione empirica. Ha un fondamento la tesi di The Knowledge Machine di Michael Strevens?
Isaac Newton nel suo grande aveva un bel problema: non credeva nella divinità di Cristo. Lo studio maniacale della Bibbia, infatti, lo aveva convinto che Gesù non fosse uguale a Dio, ma creato da Dio Padre. La cosa potrà sembrarvi banale ma nell’Inghilterra del XVII secolo questa era tanta roba e, soprattutto, una bella eresia. Le convinzioni profonde di Newton significavano che non poteva, in coscienza, essere ordinato sacerdote, il che aveva un’immediata esternalità negativa sul lato pratico: non avrebbe potuto, infatti, essere confermato fellow del Trinity College di Cambridge e professore lucasiano di matematica.
Di fronte al genio, così, re Carlo II fece un’eccezione e Newton poté continuare a frequentare Cambridge; pubblicamente si conformò ai precetti anglicani che privatamente continuava a ritenere insensati. L’episodio e la storia sono cruciali per Michael Strevens, filosofo che incentra proprio su Newton la storia delle origini della scienza. Il genio che ha scoperto la gravità ha anche messo in moto quella che Strevens chiama la macchina della conoscenza della scienza, o The Knowledge Machine usando il titolo inglese del suo libro.
Con le sue parole da me liberamente tradotte: «Se la specie umana voleva i suoi vaccini, i suoi motori elettrici, la comunicazione wi-fi (insomma, le fonti della salute, l’ossatura dell’industria e i pilastri della connettività umana) qualcosa fuori dall’ordinario avrebbe dovuto infrangere la barriera». E Newton buttò giù il muro ideando quella che Strevens chiama la regola di ferro alla base delle pretese di oggettività della scienza. Essa stabilisce che tutte le argomentazioni scientifiche devono essere condotte attraverso analisi empiriche, escludendo tutte le questioni soggettive, filosofiche, religiose o estetiche.
Oggi ci sembra banale e probabilmente il genio sta proprio in questo. Solo pochi anni prima della crisi di coscienza di Newton, un salto del genere sarebbe stato inconcepibile e questo nonostante i primi vagiti di metodo scientifico di Francis Bacon con il metodo induttivo e, in Italia, con le sensate esperienze di Galileo. Ma un coscritto di Newton, se mi si passa l’espressione, quel Renes Descartes del cogito ergo sum, fondava ancora la sua filosofia sull’intervento divino. Prima di Newton, questa era la tazza di te della comunità intellettuale; dopo di lui, l’uso dei dati divenne sinonimo di qualità intellettuale.
Che Dio si nascondesse dietro i dati o il fatto che i fiocchi di neve fossero più o meno belli, non erano questioni di pertinenza dello scienziato. «Non fingo ipotesi», scrisse con forza Newton nella seconda edizione dei suoi Principia nel 1713. Strevens definisce irragionevole questa regola ferrea perché la scienza è stimolata da impulsi soggettivi, come la miccia della scoperta e dell’idea. Essi, però, non possono avere alcun ruolo nell’argomentazione scientifica. È come se la scienza si auto-immunizzasse dall’errore che rende degno di essere compiuto.
La tesi sostenuta è che, dopo il trattato di Westfalia del 1648 che pose fine alla Guerra dei 30 anni, l’Europa cambiò profondamente: la conseguente separazione degli stati moderni laici e religiosi condusse a uno zeitgeist in cui era possibile una proficua distinzione in compartimenti stagni, come quella che praticava Newton a Cambridge. La brillante e avvincente storia di Strevens sulla felice abdicazione della scienza di fronte alla regola di ferro si fa beffe di questa stessa regola.
Egli racconta la sua storia della scienza per contrastare due narrazioni rivali. In primo luogo, i soggettivisti radicali che individuano solo potere e interessi costituiti dietro la presunta ricerca della verità da parte della scienza. L’esempio citato è quello delle compagnie del tabacco che utilizzano i dati per produrre gusti e aromi appetibili dal punto di vista commerciale. Ma in secondo luogo Strevens ci va giù pesante con due mostri sacri della filosofia della scienza: per capirci, gente come Thomas Kuhn e Karl Popper che si fanno alfieri del cosiddetto metodo scientifico. Kuhn si sbagliava, sostiene Strevens, nel pensare che la scienza faccia progressi perché gli scienziati sono incapaci di mettere in discussione l’autorità intellettuale o quello che Kuhn chiamava il paradigma prevalente. E Popper sbagliava pure a ipotizzare che la conoscenza scientifica avanzi attraverso la falsificazione delle teorie che non trovano corrispondenza nei dati.
Non esistono vincoli oggettivi all’interpretazione dei dati da parte degli scienziati, sostiene Strevens. Piuttosto, la regola di ferro consente agli scienziati di tenere la barra dritta dell’onestà intellettuale, mentre la spinta soggettiva è ciò che li fa alzare la mattina con il fuoco dentro, o come scrive lui «l’opinione grezza e incontrollata dà alla scienza una vitalità». Intendiamoci, non proprio grezza: gli scienziati, a suo avviso, usano griglie probabilistiche per determinare quali interpretazioni dei dati sono, se non ammissibili, per lo meno plausibili.
C’è tuttavia un fatto storico-scientifico che sembra falsificare il racconto di Strevens. Nel 1919, l’astronomo Arthur Eddington voleva verificare se la teoria della relatività generale di Einstein fosse capace di prevedere che i corpi dotati di massa pesante piegano lo spazio e il tempo intorno a loro, o se la tesi di Newton secondo cui la forza gravitazionale si mantiene tra essi fosse corretta. Una nave fece rotta in Brasile e un’altra in un’isola al largo dell’Africa occidentale, entrambe con un’attrezzatura per fotografare il cielo nel momento in cui la luna oscurava il sole con un’eclissi totale. Se Einstein avesse avuto ragione, i raggi di luce in arrivo sarebbero stati deviati in modo molto maggiore rispetto a quanto suggerito da Newton. Le fotografie astrografiche provenienti dal Brasile sembravano dare ragione a Newton, ma Eddington non le prese in considerazione, sostenendo che c’era un problema tecnico legato al riscaldamento eccessivo del Sole sullo specchio del telescopio. Eddington utilizzò nella sua interpretazione dei dati, dunque, solo le fotografie che confermavano il racconto di Einstein.
Questo non dimostra forse come la scienza sia passibile di errori? Certamente questo astronomo pacifista aveva una motivazione ben precisa: Eddington voleva infatti dimostrare che Einstein avesse ragione per la bellezza della teoria della relatività (dunque, con una motivazione prettamente estetica) e anche per contribuire a modo suo a svelenire i toni nell’Europa del primo dopoguerra immersa nei rancori del trattato di Versailles (motivazione politica). Strevens sostiene, tuttavia, che le misurazioni minuziose hanno dimostrato che la regola di ferro applicata da Newton fu rispettata, ma ammette che non esistevano né un tribunale né un metodo per distinguere le lastre fotografiche buone da quelle cattive: non c’era, insomma, un’autorità indipendente. La scelta di Eddington di scartare alcune foto non fu dunque scientifica, ma, come dice Strevens, ciò che spesso avviene in nome della scienza: «Discussioni di parte, manipolazioni politiche e propaganda».
Se vi suonano le orecchie per i dibattiti su Covid-19 e virologia, questo è davvero un libro che fa per voi. La scienza non solo è un accrocchio più strano di quanto un governo creda, ma è anche più strana di quanto un governo osi immaginare.