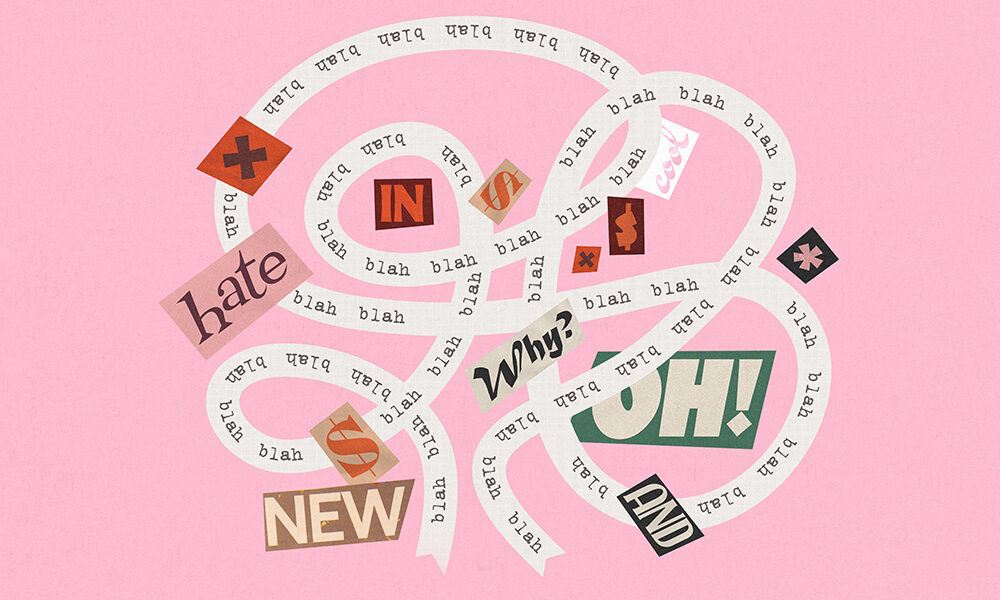Carta d’identità moltiplicata
Una ragazza apre il suo profilo su TikTok, magari con il sogno di diventare influencer, e sceglie un filtro che le modifica il viso: occhi più grandi, pelle liscia e perfetta in m
Si chiamano buzzword e sono parole o frasi di moda, abusate fino a perdere il loro significato originale. Diventano onnipresenti nel linguaggio quotidiano, per poi scomparire rapidamente.
In inglese le chiamano buzzword. Letteralmente il termine sta per “parole d’ordine” ma in senso traslato si usa per indicare lemmi, aggettivi, frasi diventati di moda, e di cui si abusa allontanandosi sempre di più dal loro significato originario e specifico. O per dirlo con la più classica delle buzzword: “virali”. Parole-ronzio che, come sciami di zanzare verbali, invadono per un certo periodo lo spazio del discorso, scritto e parlato, e per molti risultano altrettanto fastidiose. Poi a un certo punto se ne vanno e spariscono. Come le zanzare alla fine dell’estate, appunto. E le mode.
La casistica è ampia, ma il primo esempio attuale che viene in mente è “iconico”. L’ubiquità dell’aggettivo – dai titoli di giornale alla pubblicità, dagli influencer ai commentatori sportivi, dalle presentazioni aziendali in power point ai messaggi whatsapp – è pari solo alla vaghezza del significato che vorrebbe esprimere. Classico caso paradossale di termine che già esisteva in italiano – il ceppo è il greco eikón, immagine – ma che in realtà, nell’uso che se ne fa, deriva dal corrispondente inglese. Nei Paesi anglosassoni iconic è l’equivalente di “emblematico”, “rappresentativo” (alternative lessicali che ovviamente, quando si tratta di tradurlo, non vengono mai prese in considerazione e delle quali si sta lentamente abbandonando l’utilizzo, un po’ come per il punto e virgola e il “piuttosto che” inteso nel corretto senso oppositivo). Di quella accezione è rimasta nello slang odierno un’eco distante, e va da sé che a nessuno quando lo usa vengono in mente le icone bizantine. Lo si appioppa a qualunque cosa si voglia definire importante, unica o – giusto per rispolverare un altro termine passepartout di cui “iconico” è forse diventato l’erede – “mitica”. Iconici – di che cosa? non si sa – possono essere un calciatore, un disco, una pizza, un paio di scarpe, una località, un gesto. Il campo semantico si allarga a dismisura, depotenziando sempre più il senso. In un mondo in cui tutto è iconico, niente lo è davvero.
Nelle sue immortali 40 regole di scrittura – regole che con sublime ironia vengono affermate e negate nella stessa frase – Umberto Eco inserì anche: «Le parole straniere non fanno affatto bon ton». E tuttavia si ha quasi nostalgia di ciò a cui Eco si riferiva, cioè il disseminare il discorso di termini in altre lingue per darsi ingenuamente una patina di ricercato esotismo. Da tempo, infatti, siamo passati allo stadio successivo: l’italianizzazione (sarebbe più preciso definirlo imbastardimento) di parole straniere, quasi sempre inglesi, che si trasformano in mostruosi ircocervi fonetici. Come gli orripilanti “deliverare” (produrre, fornire, da deliver) o “ingaggiante” (coinvolgente, da engaging). La bruttezza dei termini non è, purtroppo, un ostacolo alla loro diffusione, come ben sa chiunque lavori nella pubblicità o nel marketing. Di peggio esistono solo i calchi ingiustificati dal corrispettivo inglese: perché dire che un disco è stato “rilasciato” (da release) quando si può serenamente dire che è stato pubblicato?
È praticamente impossibile individuare, tantomeno prevedere, il momento esatto in cui una parola diventa una buzzword. Né il perché. Semplicemente accade. Più facile forse è analizzare i meccanismi di propagazione e le motivazioni spesso inconsce che inducono a usarle. Tra i primi, se una volta si potevano citare i mass media come principali colpevoli oggi il canale sono soprattutto i social: in fin dei conti, cosa sono le buzzword se non degli hashtag mentali? Tra le seconde si possono elencare conformismo, pigrizia, impoverimento progressivo della lingua, ma a volte anche un bisogno di sentirsi rassicurati dalla presunta autorevolezza che certe parole esprimono.
Non è un caso che diversi dei tormentoni linguistici che ci affliggono negli ultimi anni siano stati estrapolati dal vocabolario tecnico-scientifico. Quante volte abbiamo sentito dire che un progetto viene “messo a terra” o “in bolla” da qualcuno che non era un fisico, un elettricista o un architetto? In quante occasioni ci si imbatte nell’espressione “big data” per parlare magari delle statistiche del campionato di basket? Da questo punto di vista, la parola regina è soprattutto una. Lei: la famigerata “resilienza”. Termine squisitamente accademico, rimasto dormiente per un’infinità di tempo, che a un certo punto è passato dall’indicare la capacità dei materiali di assorbire gli urti piegandosi al connotare una generica capacità di sopportazione individuale. Una buzzword che si ricollega, certo, anche a ciò che la parola descrive in psicologia – il saper reagire ai traumi – ma che di nuovo banalizza sia il significato sia il contesto a cui la parola viene applicata.
Le buzzword hanno una doppia peculiarità, che da un lato le rende problematiche ma dall’altro è causa del loro stesso declino. Assorbendo in sé tutti i possibili sinonimi che le persone si rifiutano di usare al loro posto depauperano anche la realtà a cui pretendono di riferirsi, eliminando tutta quella diversità e quelle sfumature che solo la ricchezza del linguaggio ci permette di descrivere. Ma proprio per questo, a lungo andare, si consumano e diventano parodistiche. Ormai nella maggior parte dei casi in cui viene citata, la parola “resilienza” è utilizzata per dire quanto non la si sopporta.
Del resto, il linguaggio non è mai neutro. Dietro l’imporsi di un termine particolare a volte c’è anche un chiaro intento politico, con uno slittamento di senso che ribalta le intenzioni originarie. Un esempio? Il martellante abuso odierno di woke. Aggettivo sostantivato che ha le sue radici addirittura nei discorsi di Martin Luther King e che per diverso tempo indicava il risveglio delle coscienze rispetto alle lotte per i diritti delle minoranze, è stato negli ultimi anni capovolto di segno e usato in modo dispregiativo da coloro che si scagliano contro chi sostiene quelle lotte. Non diversamente da “gender”, termine che di per sé sarebbe assolutamente neutro ma che ha assunto, proprio grazie all’uso reiterato in forma polemica, un chiaro connotato ideologico.